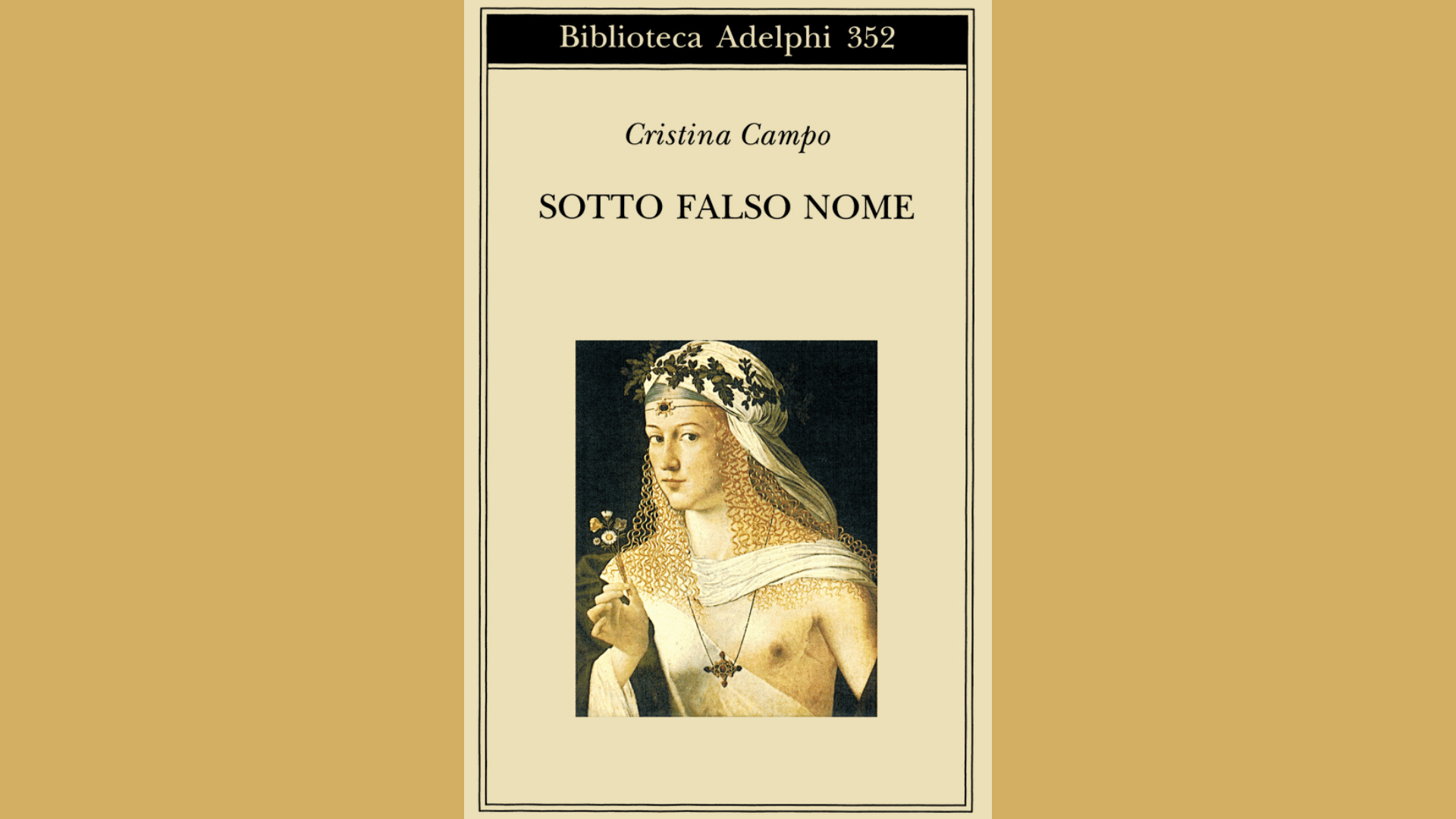A cento anni dalla sua nascita, la scrittrice e poeta si attesta come una delle voci più preziose e rare della letteratura italiana contemporanea.
da Quants numero 9, gennaio 2024
Cristina Campo è lo pseudonimo di Vittoria Guerrini, la poeta, filosofa e scrittrice che nacque a Bologna nel 1923 e morì a Roma nel 1977. Come ormai risaputo furono diversi gli pseudonimi che utilizzò per firmare i suoi testi: «colei che tanto impegno mise nell’eclissarsi, o almeno nel dissimularsi, piuttosto che nel mostrarsi» scrive la critica letteraria Monica Farnetti nella postfazione al volume Sotto falso nome (1998) da lei curato per Adelphi.
Alla giornalista ticinese Olga Amman che la intervistò, impresa più unica che rara, pochi mesi prima della sua morte, raccontò che aveva imparato da una persona degna di essere ascoltata che non bisogna mai dire il proprio vero nome, né l’esatta data di nascita e neanche mai regalare delle fotografie di sé. Aggiunge poi che Cristina Campo è un nome emerso durante un gioco da bambina con un’amica «dolcissima», uccisa dal primo bombardamento su Firenze durante la seconda guerra mondiale e che per questo ci è molto affezionata. Ad Amman, poi, che le chiede se abbia una qualche intenzione di rivelarle il suo vero nome, risponde ridendo che non ci pensa affatto.
Sono davvero vari e curiosi gli pseudonimi che Vittoria Guerrini ha scelto nel corso della sua vita per firmare i suoi testi: Giusto Cabianca, Benedetto Padre d’Angelo, Bernardo Trevisano, Puccio Quaratesi, Federica di Palma – e ognuno di questi racchiude un segreto, come scrive Farnetti: «Gli pseudonimi di Vittoria Guerrini quando non corrispondano a precisi personaggi storici, o quando alla storia non si adeguino almeno per quanto riguarda il cognome […] giocano di preferenza con l’etimologia, la fonetica, la semantica e dissimulano mentre racchiudono nella loro trama e figura sillabica un tratto rilevante della personalità di lei».
La sua devozione non le ha impedito di affilare uno sguardo lucido e attento sul suo tempo e sulla realtà nella quale, anche suo malgrado, viveva.
Eppure l’autrice dichiara in Il flauto e il tappeto, testo contenuto nel libro omonimo, che: «Dio è il battezzatore», mostrando in questa pratica di attribuirsi da sola nomi diversi quello che sembra essere il suo unico peccato.
È impossibile provare a tracciare un profilo di Cristina Campo senza nominare quasi subito il nome di Dio, infrangendo di conseguenza il primo comandamento che come risaputo ci impone di non farlo invano. Si tratta però solo di un’apparente colpa, forse, visto che la si commette per indicare una direzione fondamentale nella vita e di conseguenza nella creazione artistica dell’autrice: la via spirituale.
È risaputo che Cristina Campo si sia battuta, insieme ad altri intellettuali dell’epoca, contro il passaggio dalla messa in latino a quella in italiano, arrivando, vista l’impossibilità di arrestare quelle che un poeta da lei amatissimo, Giacomo Leopardi, definisce con sprezzo «le magnifiche sorti e progressive» a frequentare il rito ortodosso. È meno conosciuto, invece, l’approccio non esclusivamente cattolico alla ricerca spirituale che emerge nei suoi testi, il frequente ricorrere all’immagine del derviscio, il mistico dell’Islam che nella sua danza estatica persegue la ricerca di Dio attraverso la scomparsa del proprio ego, nella spirale del ballo e dell’estasi.
Questa concezione della spiritualità come dialogo privato con Dio, dell’eremitaggio per incontrare la divinità, caratterizza anche l’esperienza dei padri del deserto a cui Cristina Campo dedica, tra gli altri, un testo contenuto in Il flauto e il tappeto: «intorno a questi grandi leoni giacenti dello spirito, il mondo delle forme, come quello della parola, è pressoché abolito». E nel suo tentativo di schermirsi, ripetendo a Olga Amman di avere così poca importanza, che lei non conta nulla e che per questo non ha senso che si dilunghi a parlare di sé, Cristina Campo dimostra di aver perseguito lei stessa quella via spirituale, una pratica di annientamento del proprio ego che è comune tutte le mistiche del mondo.
La sua devozione, però, non le ha impedito di affilare uno sguardo lucido e attento sul suo tempo e sulla realtà nella quale, anche suo malgrado, viveva. In Scrittori “on show” un testo comparso ne Il Mondo del 04 settembre 1962 troviamo la parodia dello scrittore impegnato che assomiglia tanto all’autore contemporaneo, anche se a noi, che come Cristina Campo rimpiangiamo i bei tempi antichi, sembra strano. Inventando un gioco esilarante, Campo riscrive un’ipotetica intervista in cui lo scrittore “on show” racconta: «scrivo a mano la mattina, il lunedì e il mercoledì e il venerdì, ricopio a macchina il pomeriggio, il martedì il giovedì il sabato». Poi prendendosi gioco del format del programma pseudo letterario in cui gli autori si alternano finendo però per somigliarsi tutti tutti, Campo aggiunge: «poiché, come si diceva, lo schema è immutabile, riesce anche difficile ricordare, in capo all’anno di cinquantadue settimane, quale dei cinquantadue letterati amasse più di ogni cosa la pesca, i bambini e la piazza di Fiuggi Fonte, quale invece il primo Campigli, le pianole e i viaggi con l’autostop». Non manca, poi, in questo siparietto che è una perfetta e avanguardistica messa in scena della trasformazione oggi ormai compiuta dello scrittore in opinionista, il racconto delle umili origini: «da qualche mese anche i meglio educati – forse proprio perché tanto educati? – tacciono ogni eventuale discendenza borghese e indistintamente si appellano a nonni sterratori e a terribili anni nelle Saline di Aci Superna». Si tratta di una moda che non è mai più passata da allora, basti considerare la necessità che hanno gli intellettuali contemporanei, quelli che Campo definirebbe «uomini fino in fondo del nostro tempo», di ammantare origini contadine, operaie, come se il sudore della fronte dei nonni e delle nonne potesse purificarli e preservarli dall’inevitabile contagio neoliberista.
Al contrario di questi personaggi, da rotocalco o televisivi, che suscitano il suo scherno così elegante, come noto Campo dichiarò di aver scritto poco e che avrebbe voluto scrivere ancor meno: mentre era in vita considerò degne di pubblicazione solo le liriche contenute nel volume Passo d’addio (1956), silloge di cui si pentì e si dolse, e due raccolte di saggi: Fiaba e mistero e altre note (1962) e Il flauto e il tappeto (1971). E di nuovo se non si fa appello a Dio, rischiando un’altra volta di infrangere il primo comandamento, risulta difficile capirne la ragione, mentre questo approccio diventa chiaro ricordando il passo del Vangelo secondo Matteo: «di ogni parola vana che gli uomini diranno, dovranno rendere conto nel giorno del giudizio». Anche se a pensarci bene basterebbe il solo incipit delle Sacre Scritture: «in principio era il Verbo». La parola, principale strumento di creazione divina, la terrorizza, dice Campo a Olga Amman, la parola può essere terribile e allo stesso tempo essa può creare la bellezza, rappresentare la meraviglia portentosa dell’invisibile che si esplicita nel mondo: «perfezione, bellezza. Che significa? Tra le definizioni una è possibile. È un carattere aristocratico, anzi è in sé la suprema aristocrazia. Della natura, della specie, dell’idea».
Di Campo, probabilmente per l’interpretazione superficiale di frasi come questa, si legge anche che fosse di destra, nonostante i vari riferimenti che fa al mondo, al secolo, come di un luogo che non le appartiene e nel quale si muovono tante persone senza volto e senza destino. L’aristocrazia qui rimanda al suo senso letterale: il meglio, il carattere sublime e appunto perfetto che può avere un testo, o la tecnica di un grande schermidore, un trattato sui funghi come quello sui nodi di un tappeto, per riprendere parole sue. L’aristocrazia di Campo è quella dello spirito, sembra banale dirlo, fino a che non si precisa come essa venga perseguita e raggiunta: «le vigilie notturne, i duri mattutini, i voti di castità, obbedienza, povertà che essa impone».
La parola, principale strumento di creazione divina, la terrorizza, dice Campo a Olga Amman: la parola può essere terribile e allo stesso tempo essa può creare la bellezza.
Per Cristina Campo lettrice e traduttrice – si segnala rispetto alla sua attività fondamentale di traduzione il numero 36 del 2023 della rivista accademica “Cahiers d’études italiennes”, a cura di Nicola Di Nino, intitolato Con lievi mani – da quei sacrifici compiuti alla ricerca della perfezione sono nati i versi e le prose dei cosiddetti «imperdonabili», cioè gli asceti della scrittura: «imperdonabili questi a chi legga con gli occhi della carne». Campo attribuisce questo aggettivo ad autrici e autori come Giacomo Leopardi, Alessandro Manzoni, Marianne Moore, Boris Pasternak, Hugo Von Hofmannsthal… Per noi lettrici e lettori quella stessa dedizione alla ricerca della bellezza e della perfezione ha ispirato la scrittura dei testi di Cristina Campo stessa, anch’essa senza dubbio un’«imperdonabile».
La ricerca della perfezione coincide per lei con la ricerca del senso della vita, del proprio destino: «a un tappeto di meravigliosa complicazione del quale il tessitore non mostri che il rovescio – nodoso, confuso – fu da molti poeti, da molti savi assimilato il destino. Solo dall’altro lato della vita – o per attimo di visione – è dato all’uomo di intuire l’altro lato». Si tratta di un passaggio in cui Campo argomenta che la perdita della spiritualità, il ripudio dei rituali, l’allontanamento dal Simbolo, costituiscono la negazione da parte dell’umanità di ciò che di più importante le è dato, vale a dire la possibilità di farsi orecchio, scrive Campo, per ascoltare la propria vocazione.
La descrizione del destino come disegno imperscrutabile per colui o colei che lo stanno vivendo compare anche nel romanzo La mia Africa di Karen Blixen, uno degli pseudonimi della romanziera «imperdonabile» Karen Christentze Dinesen, in cui la scrittrice danese racconta una fiaba: la storia di un uomo che abita vicino a un lago e che una notte sente un rumore. Esce e cerca la perdita, cadendo, inciampando, rifacendo più volte lo stesso tragitto, fino a che non la trova e la ripara. L’indomani, dall’alto, i suoi passi all’apparenza caotici e scomposti creano la forma di una cicogna. Non a caso si tratta di una fiaba: Cristina Campo le definisce «piccoli vangeli» per la possibilità che offrono di dare accesso alla verità.
L’incontro con il proprio destino, che secondo Campo è la condizione necessaria anche alla creazione artistica, per esempio alla scrittura di un classico: «non la psicologia, non le passioni, non i caratteri fondano un classico – questo patrimonio del popolo ancor prima che della cultura – ma il sentimento soverchiante dell’incontro con un destino», passa per la pratica dell’attenzione. Molti attribuiscono alla sua scoperta di Simone Weil il ricorso che la nostra autrice fa a questo concetto, e di certo la scrittrice, mistica e filosofa francese è stata fondamentale per stimolare e ampliare la riflessione di Cristina Campo su questo tema, come su quello della grazia – anche se non guasta notare che qualsiasi via spirituale insiste sull’attenzione come unico atteggiamento utile a stare nel presente e quindi anche presenti a se stessi/e.
La ricerca della perfezione coincide per lei con la ricerca del senso della vita, del proprio destino.
Ciò che invece risulta del tutto innovativo negli scritti sull’attenzione di Cristina Campo è il fatto che sia in grado di indicarne anche i rischi, come scrive nel testo Un medico: «che cosa opporre dunque all’abitudine se non il suo contrario, l’attenzione?» che però comporta «il solo rischio terribile, quello che dà alla partita il suo alto valore: il rischio di una chiaroveggenza che stanchi l’anima fiduciosa, la sottragga alle forze misteriose del fervore, l’abbandoni senza riparo a quella enorme misura di inaccettabile che è il nucleo appunto dell’ordine del mondo. Che l’attenzione, come ogni estrema speranza, possa improvvisamente convertirsi in disperazione e, rivolta contro se stessa, assumere il volto della più letale fra le abitudini: l’inerte rassegnazione alla miseria umana».
In questa capacità di riuscire a mantenere lo sguardo fino alla comparsa inevitabile del paradosso risiede la perfezione della visione di Cristina Campo. Per lei la poesia e la liturgia, la ricerca della verità e la dedizione all’invisibile, all’Altissimo, si sovrappongono: «poesia, che è figlia della liturgia, come Dante dimostra da un capo all’altro della Commedia». Nell’intervista già citata racconta a Olga Amman che aveva potuto assistere alla recitazione del Padre Nostro in sanscrito, notando che quella preghiera altro non è se non una poesia meravigliosa.
La ricerca della verità connota tutti i suoi testi critici, seppur Guido Ceronetti non approverebbe l’uso di questo aggettivo: «saggi critici? Per niente. Non si danno giudizi. Tutto è già giudicato prima. Si va per gradi di visione. Altro non c’è». Nelle sue visioni sulla letteratura, allora, Campo liquida, per la gioia di moltissimi studentesse e studenti che in passato sono stati costretti a studiarne i volumi, l’approccio di Francesco De Sanctis, sostenendo che: «In Italia l’ultimo critico fu, mi sembra, Leopardi. Leopardi fu l’ultimo a esaminare una pagina come si deve, al modo cioè di un paleografo, su cinque o sei piani insieme: dal sentimento dei destini all’opportunità di evitare il concorso di vocali. La esaminò, vale a dire, da scrittore. A Leopardi il testo fu presenza assoluta».
Anche a Cristina Campo il testo fu presenza assoluta, cioè libera da ogni vincolo: non scrisse per ottenere riconoscimenti, non lo fece per imporre la sua opinione che traspare di rado, immersa com’è nella ricerca del racconto della verità, che sia quella scovata da Jorge Luis Borges o dai padri del deserto. E poi il testo fu a lei presenza assoluta nel senso che ha occupato tutto lo spazio della sua vita:
«Il futuro per lei cosa sarà?» le chiede Amman in chiusura dell’intervista.
«Mah, non lo so, in Russia, per esempio, ci sono dei poeti».