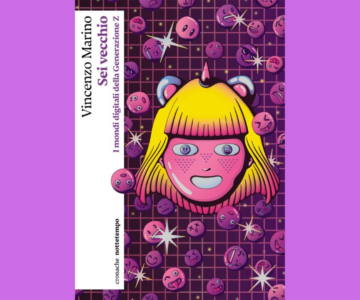Cos’è la Calabria? Ho provato a capirlo attraverso il suo principale aeroporto, tra approssimazioni, meme e luoghi comuni.
da Quants numero 10, febbraio 2024
Il mio telefono è pieno di video fatti a una porta scorrevole, una nello specifico.
Fino a qualche tempo fa, atterrato a Lamezia Terme, superato il rullo della consegna bagagli ti ritrovavi davanti a un cancello d’uscita blu notte, l’ultimo ostacolo prima di riconsegnarti al mondo. C’erano stampate sopra due gigantesche bottiglie di un noto amaro, vanto estremo del territorio. E mi piaceva immaginarmelo come una specie di stargate iper-regionale: una porta d’accesso sormontata da due enormi, inequivocabili “Benvenuti in Calabria”.
Chi frequenta spesso l’aeroporto – come me, calabrese che vive al Nord – nel tempo deve essersi abituato a questa immagine e alla sua portata metaforica, o almeno credo io: un “checkpoint” da attraversare per accedere alla regione, ai propri cari e alle palme che incorniciano i parcheggi all’esterno, ma brandizzato da un prodotto locale. Non dalle catene di autonoleggio, né dalle app per controllare gli orari dei treni: il distillato di un’azienda di Limbadi, in provincia di Vibo Valentia.
Attivo dal 1976, coi suoi grandi oblò e i colori forti da distaccamento delle poste, l’aeroporto di Lamezia è – tra i tre – di gran lunga il principale scalo calabrese. Si trova più o meno in mezzo a tutto il resto, nella piana a ridosso del Tirreno catanzarese, ed è spesso l’opzione più pratica per spostarsi altrove, laddove possibile: la più diretta, se paragonata all’offerta ferroviaria lontana dagli standard del Centro-Nord o alle mitologiche risalite in pullman verso Salerno. La più ovvia, in una regione con quasi ottocento chilometri di coste, una catena montuosa a tracciare l’unico confine, un flusso continuo di migliaia di studenti fuorisede e – prendendo in prestito la definizione di una nota mostra fotografica – un immaginario da «terza isola».
Così, sebbene vi arrivino sempre più turisti, negli anni l’aeroporto ha continuato a rappresentare il luogo da cui i calabresi partono, più che quello degli arrivi da fuori – una piazza e una porta verso un altro che non è semplicemente turistico. Milano, Roma, Bologna, Torino, Verona, Treviso, Monaco di Baviera, Düsseldorf, Zurigo, tra le mete principali dei voli. Un passaggio obbligato come un vaccino o la burocrazia che provava a rammendare la distanza col resto del mondo, o quanto meno quella percepita dal me adolescente ancora senza Internet: anni in cui tutto mi appariva lontano, dall’altra parte del Pollino, e in cui la visione dei cartelli stradali con scritto “Milano” evocava più le fiction della tv che una possibilità concreta.
In fondo, quando parliamo di “Calabria da scoprire” stiamo evocando il tema del mistero ma anche, letteralmente, il fatto che in molti non l’abbiano ancora scoperta del tutto.
La struttura stessa, d’altro canto, per anni ha provato a interpretare questa esigenza – o così ho sempre fantasticato: lontana a suo modo dall’apparire uno di quei “non luoghi” pieni di mega-shop di cui mi riempivo la testa all’Università di Arcavacata, qualche decina di chilometri più a nord, “Lamezia” offriva – magari involontariamente – una specie di sentiero iperlocale dall’ingresso all’imbarco – col lanificio storico, i prodotti del pastificio, le salsicce e i formaggi, l’artigianato e la sardella di Crucoli. La liquirizia della piana di Sibari, la pitta ‘mpigliata: un delizioso Cthulhu di miele e frutta secca difficile persino da descrivere a parole.
Non che negli altri aeroporti non esistano i prodotti del posto e le gastronomie varie, né che a Lamezia mancasse qualche classica catena, com’è ovvio: è che in questo insperato punto di scambio, nel bel mezzo di una regione così lunga e piena di vuoti, sembrava quasi più facile trovare prodotti effettivamente locali che profumi generici ed essentials da stazione di servizio. Più per utilità pratica e rappresentanza, che per iperturismo. Una credibile “Calabria in provetta” sicuramente appetitosa agli occhi dei vacanzieri, ma utile anche al calabrese in partenza per ricordare a pochi metri dal gate di comprare qualcos’altro di non facile reperibilità altrove. L’idea della provvista per un viaggio lontano dall’isola.
L’ho fatto spesso, tornando verso Milano e chiedendomi per quale motivo avessi rifiutato il “pacco” debitamente approntato dalla mia famiglia (soppressata, melanzane sott’olio, piccole creme al peperoncino dai nomi ironici). «Niente busta, grazie!» salutavo adottando la versione centro-meridionale di quello che al Nord sarebbe stato un sacchetto, per assicurare al proprietario del negozio che non fossi un turista dai tratti sospettosamente locali (con una singolare passione per insaccati e altri prodotti del territorio), ma uno di loro, per quanto di quelli che ormai stanno da un’altra parte.
Forse priva del potente immaginario pop di una Campania o una Puglia, delle gondole e degli spritz sui Navigli, per anni mi sono chiesto se la Calabria avesse in effetti un simbolo commercialmente unificante, riconosciuto e alla stregua di altre regioni. E parlo di qualcosa del livello di un meme o di un luogo comune condiviso: non per forza di culturalmente valido, ma con lo stesso portato iconico di un pesto o di una casa a forma di trullo.
Non che debba necessariamente trovarne uno, che sia per forza un male non averlo, o che non abbia comunque bellezze e possibilità comparabili a quelle di altri posti – in fondo, quando parliamo di “Calabria da scoprire” stiamo evocando il tema del mistero ma anche, letteralmente, il fatto che in molti non l’abbiano ancora scoperta del tutto. È che ormai sembra obbligatorio qualcosa del genere, quasi essenziale in un mondo che premia la sintesi e riduce tutto a un link in bio, che impazzisce per i murales da urbanismo tattico coi santi laici del quartiere, gli scorci instagrammabili e le tradizioni senza vera tradizione.
Negli anni l’aeroporto ha continuato a rappresentare il luogo da cui i calabresi partono, più che quello degli arrivi da fuori: una piazza e una porta verso un altro che non è quasi mai semplicemente turistico.
Anche adesso che, prendendola con piglio più “contemporaneo”, è quasi ovvio pensare che questi simboli possano provenire dai social network, specie da TikTok: dove la viralità di un contenuto può essere così esplosiva e casuale da diventare inspiegabile, e dove i contenuti genuini e a carattere territoriale finiscono spesso per venire premiati, per qualche ragione.
È qui che già da tempo personaggi di origine calabrese, revisionando ai giorni nostri i tormentoni regionali tipici dei vecchi show alla Zelig («Oh, Franco!»), sono diventati a loro modo rappresentativi di un territorio e noti a un pubblico largo, giovane e misurabile, coi loro riferimenti culturali, l’inflessione dialettale e le immancabili menzioni alla gastronomia – penso alle sveglissime sorelle catanzaresi che immortalano da mesi le loro colazioni salate, al giovane pastore che parla con le capre sulle alture di Belcastro, o all’avvocato di Roccella Jonica ossessionato dall’inquadratura in videocamera del suo muscolo trapezio, personaggi apparsi in tv e finiti a collezionare milioni di visualizzazioni.
Ed è qui che un prodotto della tradizione come la ‘nduja è persino riuscito a diventare virale, protagonista di migliaia di video sui social in cui utenti da tutto il mondo la spalmano come fosse salsa chipotle (altro topos: la cucina calabrese “è piccante”, come quella messicana), parlandone sconvolti come di un prodotto squisito e versatile in assonanza con un trend a quanto pare globale.
Per anni mi sono chiesto se la Calabria avesse in effetti un simbolo commercialmente unificante e riconosciuto, che fosse, alla stregua di quelli di molte altre regioni, anche un meme o un luogo comune.
Forse la cosa più vicina ad essere “il nostro pesto”, la ‘nduja è da più di qualche anno oggetto di una crescita velocissima e costante nei principali mercati internazionali. E, social network a parte, oggi puoi vederla usata nei programmi di cucina all’estero, dove finisce ormai un quarto della sua produzione. O citata da TasteAtlas che la definisce «miglior salume al mondo», per quel che vale. O al centro di una «nuova ossessione in UK», secondo Gambero Rosso. Il risultato è che se cerchi “‘nduja” su Google Trends, e selezioni un paese estero, scopri che la linea della tendenza negli ultimi anni è sempre in ascesa, ed è in splendida forma. L’altro giorno ho pubblicato un grafico relativo ai dati inglesi nelle mie storie di Instagram, e ho ricevuto solo reazioni sorprese e ironiche.
Eppure non può bastare, specie su piattaforme digitali dove la parola “fama” spesso vuol dire poco o per poco tempo, e dove la mia esperienza d’uso è diversa dalla tua. Così, in una regione senza capitali (nel senso delle città) che va dai bizantini allo stoccafisso, dalle case a punta in Aspromonte alle comunità italo-albanesi, l’aeroporto di Lamezia Terme restava probabilmente una specie di simbolo superiore e sincretico, coi suoi pregi e i difetti. Se non per gli altri, almeno per noi: un luogo funzionale e senza epica che ha silenziosamente contribuito a costruire l’idea di Calabria più vicina possibile a un sunto, una fusione a freddo di province vicine ma spesso distanti per chilometri e talvolta per cultura, distese in genere alle pendici di qualche scomoda catena montuosa.
A dicembre sono atterrato a Lamezia Terme per le feste di Natale, e ho scoperto un paio di novità. Il “portale d’accesso” era tutto blu, senza più bottiglioni. E di ritorno, di fronte ai primi cinque gate, un duty free di più di duecento metri quadri sostituiva i vecchi negozi di specialità locali coi sui prodotti di vario tipo, i cartelloni linguisticamente simili a delle slide di Powerpoint, e gli inviti ad assaggiare il taste calabrese.
È uno di quei posti aperti, senza pareti e super luminosi, in cui ti sembra di entrare per caso e non ricordi come – o dove, se a Linate o a Parigi Orly. Offre un vasto assortimento «profondamente legato alla splendida» regione «e in particolare al made in Italy», si legge sul sito dello scalo, «e sarà via via integrato con proposte di eccellenze Food & Wine» con l’obiettivo, riportano i media, di «superare quel certo provincialismo» e «aprire a marchi nazionali e internazionali».
Ancora oggi mi chiedo quale possa essere un simbolo per la mia regione, e a volte penso al gate di Lamezia, la porta della Calabria, piena di studenti all’imbarco che forse non torneranno indietro.