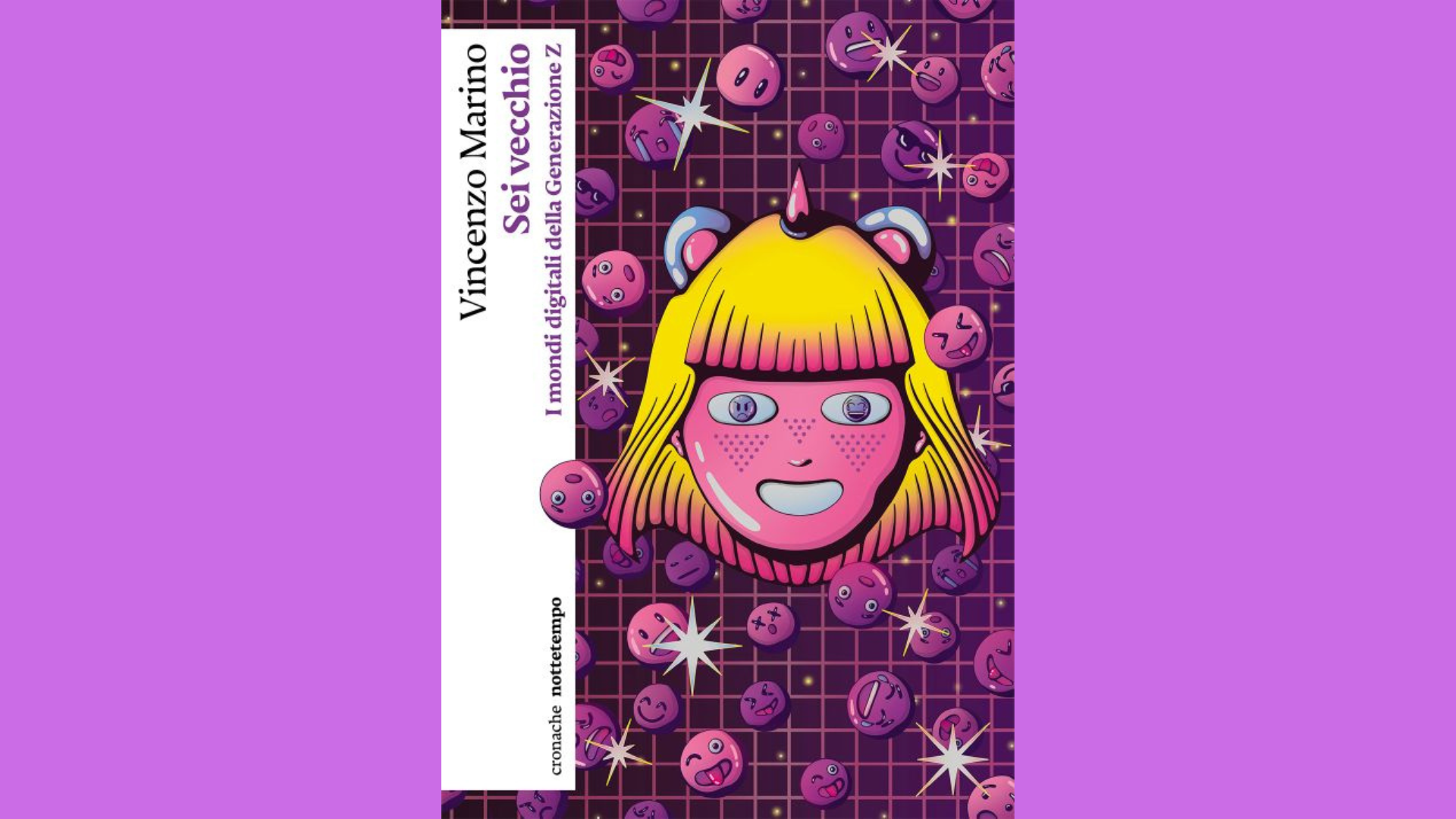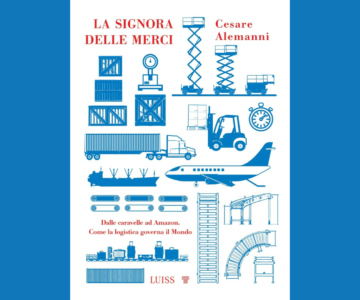Che cosa guardano tutto il giorno i nati tra il 1997 e il 2013 sul telefono, e perché? Ma, soprattutto, che cosa ci possono dire questi contenuti del mondo in cui viviamo e di come le nuove generazioni si apprestano a viverlo?
Intervista a Vincenzo Marino, autore di Sei Vecchio. I mondi digitali della Generazione Z.
da Quants numero 2, maggio 2023
Lo scriveva anche Domenico Latino, il direttore responsabile di questa rivista, nel suo editoriale del numero precedente: da sempre chi è più adulto fa fatica a capire e comunicare con le nuove generazioni. Figuriamoci quanto questa difficoltà possa essere estremizzata in un momento in cui l’innovazione tecnologica e il continuo proliferare di novità hanno creato una totale scissione per la quale realtà protagoniste dell’immaginario di una certa fascia di età sono completamente sconosciute a chi abbia anche solo qualche anno in più. Lo vediamo per esempio nella musica, dove perfino i dominatori assoluti delle classifiche di vendita sono costretti ad andare a Sanremo per riuscire a farsi notare da un pubblico non soltanto giovanile (è stato il caso di Rkomi nel 2022 e di Lazza nel 2023).
Vincenzo Marino, che ha 37 anni ed è praticamente mio coetaneo, si trova come me in quella strana posizione di mezzo, per la quale abbiamo visto il mondo prima, ma siamo anche testimoni di quello nuovo; e un po’ per curiosità e inclinazione personale e un po’ anche per lavoro cerchiamo di capirci qualcosa di più, potendolo osservare e analizzare con strumenti maggiori rispetto a chi, destinatario naturale, ne fruisce soltanto più o meno passivamente. Vincenzo lo fa molto più di me — io non riuscirei a sottopormi alla stretta e costante dieta mediatica fatta di infinite sessioni di scrolling su TikTok e fruizione di dirette Twitch che sono ormai il suo pane quotidiano, ma è per questo che è diventato una specie di punto di riferimento per chi vuole capire che cosa succede sugli schermi che costituiscono la realtà quotidiana di quella che viene definita Gen Z. Lo è diventato dapprima con una newsletter, Zio, e ora con il libro (Sei Vecchio. I mondi digitali della Generazione Z, nottetempo 2023) che di questa rappresenta una sorta di espansione e approfondimento.
Ne abbiamo parlato con lui.
Come nasce il progetto di questo libro? O meglio come nasce la tua curiosità in merito a queste tematiche?
La curiosità nasce dalla tendenza a spiegarmi cose, a immaginare meccanismi, che mi porto dietro sin da piccolo — sono un rimuginatore. Col tempo ho provato a farne un lavoro, cominciando a scrivere prima sui blog e poi su testate e magazine, fino a che con VICE, una decina di anni fa, ho trovato il suo punto di approdo più naturale: una rivista online young-oriented sulla quale poter parlare in profondità di cose apparentemente irrilevanti, e guardare al mondo con uno sguardo diagonale.
Dopo un po’ di esperienze di tutti i tipi, nel 2019 ho deciso di cambiare vita professionale lasciando il mondo dell’editoria, ma provando a tenermi un piccolo spazio in cui poter scrivere per non perdere il vizio.
In quel momento, le newsletter erano la nuova cosa: un giorno un mio amico mi chiede spiegazioni su chi fosse questo ThaSupreme, all’epoca l’emergente più chiacchierato della scena musicale, e io gli rispondo con un muro di testo. Ho amato ogni secondo di quello spiegone, e intuito che molti miei coetanei — avevo 34 anni — ignoravano una parte molto rilevante di quello che accade sui social, soprattutto quella abitata dai più giovani. Quindi ho lanciato “zio”, la mia newsletter: ora ha più di tre anni, e la struttura per ispirare un libro.
Ho cominciato muovendomi per macrotemi una volta a settimana: TikTok, Fortnite, quel tipo di fenomeni che prima o poi si rischia di incrociare, senza magari saperne troppo. Poi ho affinato la formula: l’ambizione è sempre stata quella di non avvicinarmi al tema del momento — esempio: spiegare cosa volesse dire “ok boomer” o “cringe” — ma cercare di anticipare i tempi restando sempre diagonale.
E quindi, piuttosto, provare a definire l’espressione “no cap” (non mento, niente bugie) per parlare del rapporto dei giovani con le fake news. O raccontare il mondo sommerso delle cosiddette “stream ludopatiche”, live in cui creator impallinati per le slot machine online passano ore a perdere anche migliaia di euro.
Il modello della newsletter si è confermato quello più giusto, per la sua capacità di creare comunità, di essere consumata con tempi più dilatati. Farne lo spunto per un libro è stata una bella sfida: non facile, perché è pur sempre il mio primo. Ma l’ho sentito quasi naturale, per poter dare più respiro alla ricerca e portare libro e lettore in una direzione più precisa.
«Ammetto di non credere alle categorizzazioni generazionali — voglio dire, nessuno è l’anno in cui nasce. È però evidente che il panorama sociale e culturale in cui si cresce è rilevante. Ed esercita una sua influenza».
Come hai scelto, da un infinito oceano di contenuti, su cosa concentrarti? Cercavi qualcosa che potesse nascondere tra le righe anche significati ulteriori oltre a quello che è esplicito?
Esatto. Ogni storia di cui scrivo in Sei Vecchio è legata alle altre da un filo sottile, a cui pagina dopo pagina ho voluto dare sempre più centralità. Si parte con un intero capitolo su un singolo creator, GSkianto, e infine si arriva a tracciare una traiettoria quasi politica — che i casi di cui parlo non fanno che aggiustare e rendere più nitida.
Poi chiaramente parte delle storie sono state scelte anche perché mi aiutano a disegnare meglio questo paesaggio grazie alla loro notorietà: i casi di Donato e della capra calabrese sono arcinoti, per esempio. Ma provo a rileggerli con una lente critica nuova.
Si fa tanto parlare di Gen Z cercando anche di definirla. È un’impresa possibile? Da quello che sei riuscito a capire ci sono delle caratteristiche comuni che si potrebbero evidenziare?
Parto da una premessa: sia nel libro che sulla mia newsletter ammetto di non credere alle categorizzazioni generazionali — voglio dire, nessuno è l’anno in cui nasce. È però evidente che il panorama sociale e culturale in cui si cresce è rilevante. Ed esercita una sua influenza.
Acquisito il dato, ho provato a raccontare questo quadro analizzando l’offerta dei contenuti digitali di oggi: da un lato perché è sulla rete che i ragazzi sotto una certa soglia anagrafica trascorrono le loro giornate, secondo decine di studi. E dall’altro, perché i fenomeni di internet sono più facilmente analizzabili: ci sono i numeri, ci sono i commenti, esistono trend oggettivi. Sono palesi, se si hanno i mezzi per capirli.
Per esempio, il successo di contenuti in cui emerge l’esigenza dell’essere visibili, del manifestarsi, e dell’uso dei social network come piattaforma performativa, si sposa perfettamente coi casi in cui la fama istantanea di alcuni personaggi esplode per poi incenerirsi dopo poco. O con la gigantesca offerta di contenuti “motivazionali”. O addirittura con certi testi e certe dichiarazioni dei trapper.
Nell’ottica del “vedere qualcosa di ulteriore” mi incuriosisce molto il discorso sulle collab house, nella loro ricerca di una funzionalità quasi industriale. Ci racconti che cosa sono?
Una delle “trame” del libro è: tutto è ormai content, persino le nostre stesse vite. Ed è tanto più vero nelle “collab house”, o “content house”, dove agenzie o collettivi di influencer aggregano manciate di giovanissimi creator, invitandoli a vivere sotto lo stesso tetto ma invitandoli a usare la casa come stage per i loro contenuti — sia quelli organici che quelli promozionali.
È come una specie di Grande Fratello, dove però la telecamera è quella dei loro iPhone: esattamente come nel programma tv gli spazi della casa sono brandizzati, e in alcuni momenti della giornata, come il pranzo, può capitare magari che vengano mostrati prodotti a favore di camera per esigenze di branding — per una collaborazione con un marchio alimentare, per esempio.
Sopra una certa soglia anagrafica, a meno che non si lavori nel settore, si conosce molto poco delle “collab house”. Eppure la creator più famosa d’Italia in questo momento, Alessia Lanza, si è formata ed è cresciuta proprio dentro una di queste.
È come una specie di Grande Fratello, dove però la telecamera è quella dei loro iPhone: esattamente come nel programma tv gli spazi della casa sono brandizzati, e in alcuni momenti della giornata, come il pranzo, può capitare magari che vengano mostrati prodotti a favore di camera per esigenze di branding.
Sul finale del libro si delinea il pericoloso spettro del “mindset vincente”, che sembra stare contagiando la Gen Z attraverso i contenuti digitali più di tante tendenze comunemente raccontate con toni allarmistici. Che cos’è? Rischia davvero di diventare pervasivo nel sistema valoriale di una generazione?
Ti faccio un esempio: hai mai visto un vecchio musicista italiano pubblicare un post su Facebook o Twitter con la foto del disco d’oro? O hai mai visto magazine musicali di cinque o dieci anni fa pubblicare su Instagram la fotona con l’artista e la grafica col disco di platino, ogni volta che escono delle certificazioni FIMI?
Chiaro, sono cambiati i tempi — velocemente. È cambiata la musica, sono i testi stessi dei musicisti oggi premiati a parlare di rivalsa e ostentazione, e in più sono cambiate le piattaforme. Ma la stessa corsa all’affermazione personale e al dimostrare di avercela fatta, nel libro la accosto a questa nuova tendenza digitale, a questo tormentone — mezzo meme e mezzo pensiero magico.
Da anni circolano video in cui ci si spiega come fare i soldi e avere una mentalità vincente. La novità è che adesso sembrano aver fatto questo salto evolutivo, circolano su TikTok, coi loro nuovi piccoli e grandi influencer, e condizionano parte della produzione digitale online. I messaggi sono per lo più degli epici sproni a mettercela tutta e a emanciparsi economicamente, e arrivano a volte a delle derivazioni ultra-liberiste, machiste, perfino aggressive: come la teorizzazione di un maschio nuovo, evoluzione del famoso “alpha”, che sa quasi di “Übermensch” nietzschiano.
È un “sentire comune” condiviso genuinamente da buona parte dei creator italiani, che spronano i loro fan a “non pensare al fallimento” e ad avere un “mindset orientato solo al successo”, come dicono loro.
Sembra che di base ci sia un forte elemento di individualismo, di cui sono sia figli che promotori. Manca l’idea di una prospettiva collettiva. Però allo stesso tempo si parla di una generazione attenta come nessuna prima d’ora alle questioni ambientali e ai diritti civili: come possono convivere questi due aspetti?
Difficile trovare una risposta corretta, ammesso che esista. La cosa certa è che i consumi culturali — che sono quelli su cui mi concentro — sono sicuramente globali, immediati: ci sono istanze con cui tutti siamo necessariamente portati a fare i conti (pandemie, guerre, riscaldamento globale) e gli strumenti giusti per farne una conversazione diffusa.
In questo senso, quello della Gen Z è quasi necessariamente uno sguardo ampio, sia sui temi più prettamente “politici” che sui consumi mediali: difficile immaginarsi una serie coreana diventare un successo globale pochi anni fa, per dirne una. O una protesta di teenager nord europei contagiare il resto del mondo.
Penso però che questo corredo di input diffusi, malgrado tutto, non ostacoli una certa pulsione all’individualismo: c’è sì un mondo che cambia sotto i nostri occhi, ma addomesticato da feed e algoritmi modellati sui nostri interessi.
I media mainstream di oggi sono in difficoltà, e lasciano a un’intera generazione il compito di auto-rappresentarsi come può.
È ancora possibile un dialogo intergenerazionale, tra persone che forse più che mai seguono diete mediatiche completamente diverse? E può portare a qualcosa di buono? Sei un ottimista o meno, da questo punto di vista?
Pessimista: per me è fondamentale lo studio, la comprensione e il dialogo. Bisogna provare ad analizzare certi meccanismi per non perdersi di vista.
Poi purtroppo è vero, i contenuti creati “per e da” i nuovi utenti della rete appaiono il più delle volte impossibili da capire se non si frequentano assiduamente le piattaforme e non se ne colgono i sistemi: la prima volta che ho visto una live “IRL”, ossia una di quelle dirette attraverso le quali i creator interagiscono con la propria community camminando in streaming per la città, ho pensato di essere ufficialmente, irrimediabilmente troppo vecchio per capirla. Ci ho messo un po’, è oggettivamente ostico.
Inoltre, i media mainstream di oggi sono più in difficoltà — sia in generale, che nella comprensione dei giovani — di quanto non lo fossero prima. Lasciando a un’intera generazione il compito di auto-rappresentarsi come può.
Mi chiedevo appunto quali fenomeni anche uno come te, che ha una certa esperienza e abitudine, faccia più fatica a capire. Quali ti fanno chiedere «Ma davvero questa cosa funziona? Perché?»
Alla fine un perché lo trovi quasi sempre: la diretta con il tipo che spella l’uovo sodo pezzetto dopo pezzetto, o quella con l’altro che impila dei bulloni fino a farli cadere, per quanto incomprensibili possano apparire vanno a — per esempio — solleticare la nostra curiosità, e ci invogliano ad aspettare che l’inevitabile s’avveri: lo sgusciamento completo dell’uovo, la caduta dei bulloni. C’è persino chi si trasmette in diretta mentre porta avanti un contatore a colpi di click sul mouse, senza una meta.
Una cosa su cui però indago da mesi, e alla quale cerco di trovare un perché, è l’incredibile successo su TikTok dei contenuti provenienti da Napoli: la salumeria, la pescheria, il negozio di vestiti per bambini, il ragazzino che fa gli hot dog per strada, il proprietario dell’autorimessa, l’esperto di frasi motivazionali volutamente sgrammaticate. A turno i loro motti e le loro clip diventano virali. Voglio trovare un pattern, non mi dò pace.
Parli di autorappresentazione però le content farm, i grandi brand, l’influencer marketing, la corsa al talent… Sono tutte cose decise più in alto, da persone che non appartengono alla gen Z ma ne estraggono valore.
Vero, anche perché il mondo della pubblicità è sempre molto sensibile nell’intercettare tendenze e nuovi linguaggi: lo vediamo per esempio nel tentativo dei brand di mostrarsi genuini, autentici, come fossero dei content creator. O dai progetti dove sono i creator stessi a farsi portavoce di un marchio declinandolo nella loro narrativa.
È un modello, però, che è nato spontaneamente sui social, e che si è imposto poi all’attenzione del content marketing — non il contrario. Tant’è che le aziende continuano a far fatica a far sembrare il loro messaggio “organico”, spesso incontrando i “cringe!” dei follower nei commenti.
Penso per esempio a un tipo specifico di video TikTok, che gira molto in questi giorni: ci sono diversi account ufficiali di brand che hanno ripreso una tendenza nata dal basso, in cui — con un filtro e una canzone — si mostra la sede dei propri uffici sormontata da un gattone seduto che saltella.
Ce ne sono a centinaia, tutti uguali. E quasi tutti criticati. Quale valore aggiunto si può estrarre da un contenuto del genere?