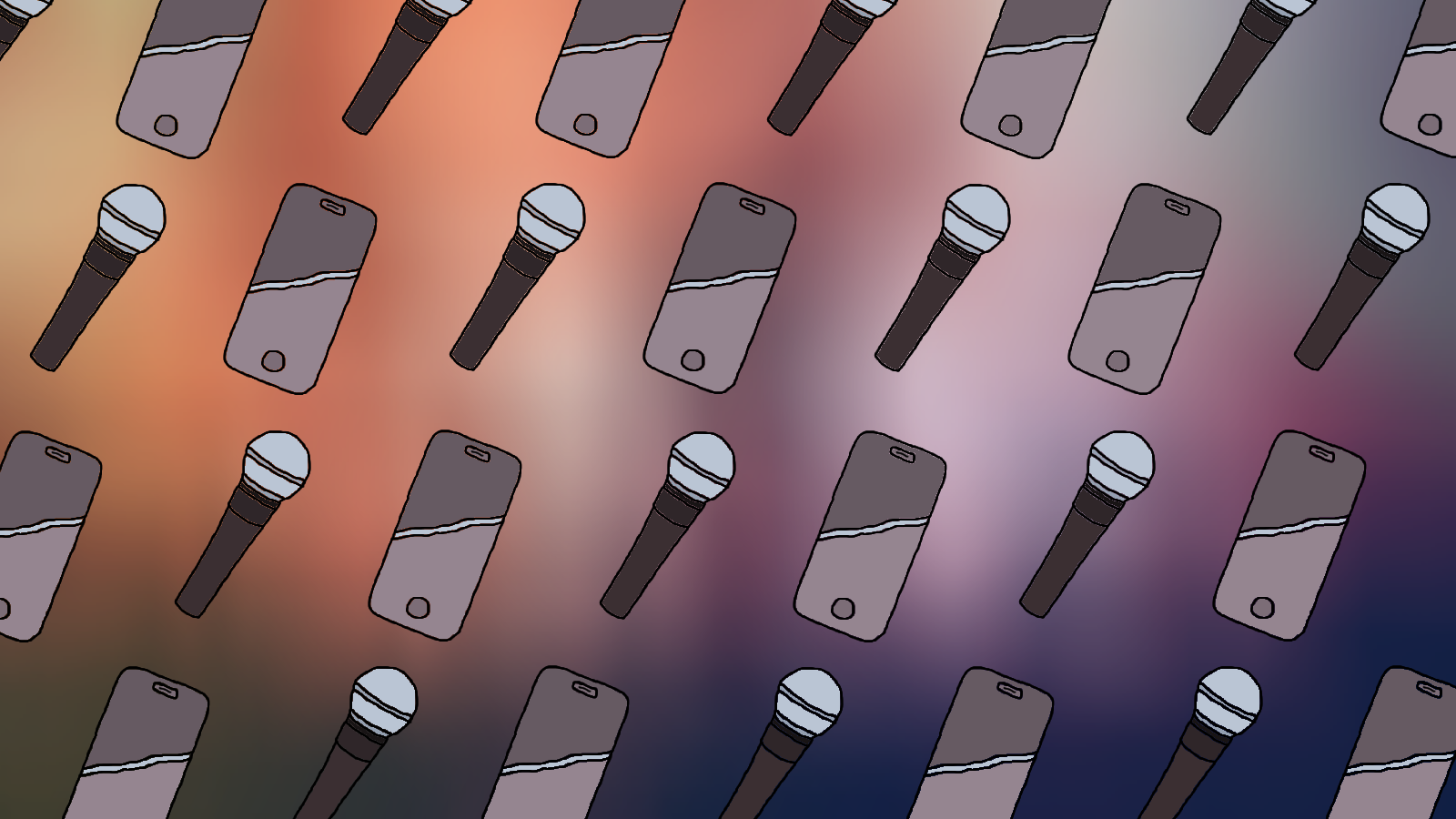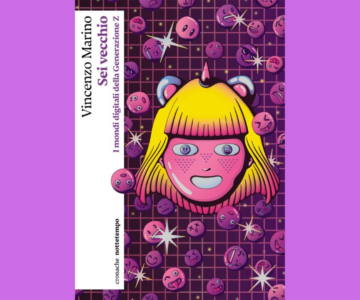Il rap è cambiato. E tra progetti coi brand e apparizioni social, a volte è difficile capire dove cominci la musica e finiscano i piani marketing — o forse sono solo troppo adulto per capirlo.
da Quants numero 5, settembre 2023
Ho scritto questo pezzo tre volte, forse di più.
La prima, ho provato a parlare del rapporto tra il rap italiano di oggi e la cultura. Così: per capire se fosse vero — citando un’intervista allo speaker di Radio Deejay Wad — che i rapper in Italia non «regalano qualcosa» dal punto di vista intellettuale. Che «non sono colti».
Ho cercato di catturare istantanee, tracciare la parabola che dalle periferie porta al palco dell’Ariston. Di capire cosa fosse “cultura” e cosa meno.
Niente, difficilissimo. Sconfitto, alla fine ho sentito Federico, il direttore editoriale di questo magazine. Gli ho detto papale in una nota audio che non ci riuscivo, che «Fede… Non c’è verso che questo articolo porti a qualcosa, scusami». A proporlo, in fin dei conti, ero stato io.
La seconda volta ho scelto un approccio più comodo, uno sport a cui autori e giornalisti della mia età sono più allenati dai tempi dei blog su WordPress: spiegare perché i media mainstream, nelle loro fumose e antistoriche stamperie, di questo fenomeno non abbiano capito ancora molto.
E quindi giù a chiedersi come mai, sebbene il rap di nuova scuola fosse già da anni più di una tendenza, su giornali e tv venisse ancora raccontato con le stesse domande e rappresentazioni del primo Jovanotti. O associato artificiosamente alla microcriminalità urbana. O descritto — nella migliore delle ipotesi — da scene viste forse solo sul copione di 8 Mile, il film di Eminem del 2002. Come se gli anni Novanta fossero passati invano: sempre il cappellino all’incontrario, e uno “Yo!” ancora solido in ogni tasca.
Anche qui, però, nulla. Stavolta senza avvisare.
La terza volta ho capito che forse dovevo prima spiegare qualcosa a me stesso: fare pulizia sulla figura del rapper oggi, e come questa penetra nel nostro quotidiano — sempre meno grazie alla sola offerta musicale o al rap per sé, sempre più attraverso i personalissimi palinsesti d’intrattenimento che ci costruiamo ogni giorno, quando accediamo ai social. Dovevo capire perché, in pratica, di questo mondo qualcosa ancora non ci torna.
Secondo diverse ricerche questa figura eserciterebbe un fascino significativo sui giovani della Generazione Z, riuscendo a parlare loro con codici attraenti e contemporanei: ad oggi, dice un sondaggio commissionato da Adobe, il 45 percento degli appartenenti a quella fascia demografica ambirebbe a diventare un creatore digitale.
È l’estate del 2023, e mentre scrivo l’urban — quel genere che unisce rap, pop e scenari “di strada” che va da Geolier a Blanco — è diventato la colonna vertebrale della musica leggera italiana. Troneggia nelle prime posizioni delle classifiche di vendite e di streaming, occupando le varie top 20. Presidia costantemente il Festival di Sanremo, con partecipazioni vincenti e fruttuose comparsate, e ha ormai penetrato la cultura popolare, affascinandola con la sua estetica e imponendo un nuovo jet set.
Lasciandosi in buona parte alle spalle gli anni in cui compromettersi con generi più leggeri e commerciali voleva dire rinnegare la purezza delle origini, parte di rap e urban sono riusciti a presentarsi come nuovi davanti al grande pubblico, pur restando spendibili nella scena core, quella purista. A finire tra gli ospiti dei maggiori eventi televisivi, pur raccontando spesso anche storie dure e difficili.
Un genere rivoluzionario ma allo stesso tempo radiofonico, in grado di parlare con immediatezza d’amore e vacanze al mare, pur provando a mantenere un immaginario selvaggio, crudo, ben codificato. Un puma in salotto, un mistero insoluto.
Estate ‘23, dicevamo: sul palco di un festival promosso da qualche noto brand, due personaggi in teoria distanti tra loro stanno duettando sulle note di “In taxi sulla luna”, la loro primissima collaborazione. Lui, romano, è Tony Effe: uno dei padrini della trap, quel genere americano nato dal disimpegno e dal racconto di storie di periferia e spaccio, esploso in Italia attorno al 2015. L’altra, storica vincitrice di Amici, è Emma Marrone — una delle regine della melodia cantata, della musica leggera “vecchia maniera”.
«In taxi sulla luna.. Sulla luna…» sibila Tony dal palco, col solito stile senza troppi fronzoli, come fosse una concessione al pubblico, più che una performance prettamente canora. Di fianco, Emma lo supporta con delle “sporche”, quelle frasi utili a coprire buchi o a enfatizzare termini: dei “bitch!” ben assestati, sulle note di una traccia che un tempo non avremmo mai pensato possibile per nessuno dei due. Eppure.
Eppure il brano ha — sì — qualche passaggio lirico più urban, con riferimenti a dei «trip» dentro al «drink», a «orologi d’oro» e fondoschiena «giga», ma è candidamente pop, tanto da finire nei primi quindici posti delle classifiche estive. Ha un impianto house, da discoteca, classicamente radiofonico, eppure è “nuovo”, un’altra cosa: vive di «occhi grandi» che se ti guardano «ritorna il sole», ma vuole provare a restare rap.
Così, pur alternandosi al microfono su un pezzo pop che parla di darsi «duecento baci al rallentatore», Tony sembra non voler abdicare alla sua immagine da rapper, al suo status di “cattivo ragazzo” dai brutti pensieri. E torso nudo, pettorali notevoli, poco dopo si ripresenta sul palco infilando una sequenza di «Go… Go… Go… Go Tony…».
Il pubblico solleva il braccio libero — l’altro regge il telefono — e comincia a muoverlo a tempo, abbassandolo e alzandolo sul beat di “In Da Club” di 50 Cent, uno dei pezzi rap più famosi di sempre. «Go Tony, prendi i soldi…», continua lui: è la cover del leggendario brano americano, di cui prende in prestito la base. Ma è anche, allo stesso tempo, il nome della sua nuova linea di energy drink.
Commentare con tono moralistico le iniziative commerciali in cui buona parte dei rapper di nuova generazione sono coinvolti, raccontando di una scena magari avida e spudorata, suonerebbe anacronistico, controintuitivo e forse ingiusto — specie se parliamo di un mondo in particolare, come quello del nuovo rap, in cui guadagnare o brillare non è un’offesa all’arte o al buon gusto, ma parte dell’ethos di riferimento.
Oltretutto, non merita neanche d’essere ignorato chi scrive e canta per urgenza artistica, o chi sfrutta legittimamente le leve del marketing per amplificare il lancio di un disco. O i diversi professionisti del settore che si sono visti crescere la creatura da sotto i piedi e stanno provando ad addomesticarla, per esempio.
Eppure, quello stesso spaccato che in pochi mesi ha prodotto linee di cereali personalizzate dai trapper, e soft drink lanciati in compagnia di Flavio Briatore, ci può aiutare a guardare l’urban e alcuni dei suoi maggiori interpreti in modo diverso: come portatori di un immaginario spendibile in qualche piano editoriale, oltre che in un repertorio musicale. Come qualcosa di effettivamente nuovo, da provare a capire davvero.
Partiamo da qui. Da qualche anno, nell’universo pubblicitario e non solo, ha cominciato a circolare una sorta di buzzword, una parola alla moda. Creator economy: una struttura di marketing basata sulla produzione di contenuti sulle piattaforme digitali (che siano video, audio, immagini o podcast, per esempio) con un valore che, secondo Goldman Sachs, ad oggi ammonterebbe a circa 250 miliardi di dollari.
A sostanziare sia il termine che il comparto, sono i cosiddetti creator: utenti social con interessi e passioni diverse, in grado però di creare una comunità di follower forte, verticale e rilevante rispetto a specifici contenuti, e quindi di diventare appetibili per i brand.
Creator, quindi, sarà il ragazzo che parla di sneaker per il gusto di farlo, o magari per una recondita voglia di emergere, che può venire poi avvicinato da Foot Locker o Nike. È lo chef amatoriale che condivide ricette, e che l’agenzia pubblicitaria magari intercetta per proporgli una partnership col cliente del settore food. È chiunque produca contenuti, e riceva attenzioni qualitativamente o quantitativamente superiori a una certa soglia.
Malgrado per i grandi media resti ancora un’entità semi-leggendaria, secondo diverse ricerche la figura del creator eserciterebbe un fascino significativo sui giovani della Generazione Z — quella dei nati tra il 1997 e il 2012 — riuscendo a parlare loro con codici più attraenti e contemporanei: ad oggi, secondo un sondaggio commissionato da Adobe, il 45 percento di loro ambirebbe a diventare un creatore digitale, e addirittura 50 milioni di persone nel mondo, secondo SignalFire, ammetterebbero di sentirsi già tali.
L’idea è quella di accedere a un circuito di individui speciali e gente comune, che è riuscito a sfruttare i social in modo credibile, e che continua a suonare “alla mano”, domestico, raggiungibile. Qualcuno che ce l’ha fatta, restando sempre sé stesso. Che è partito dal niente, e che ora si gode i più grandi palcoscenici d’Italia col proprio contenuto distintivo. Esattamente come fa un rapper.
L’esigenza è quella di costruire una comunità di affezionati al di là del confine musicale e discografico, ampliando il proprio target e rendendosi appetibili, se necessario, per nuove opportunità commerciali — nuovi cereali, nuovi energy drink, nuove partnership d’ogni sorta.
Sono gli stessi artisti a farsi ritrarre con in mano le magnum di vodka del brand partner, giurando di essere ancora “quelli dei palazzi”. A stendere distese di banconote variopinte nelle stories di Instagram, ricordando di non essere cambiati per niente e di andare in giro senza scorta. Gli stessi a raccontarsi come personaggi genuini, all’interno di uno storytelling in cui la musica è parte del racconto, ma non il romanzo per intero.
Non a caso, nel mondo anglosassone e sempre più anche nel nostro paese, già da diverso tempo il confine tra artisti e content creator ha cominciato a farsi poroso: si va dal canale YouTube per i contenuti non musicali del rapper NLE Choppa, ai fortunati esordi musicali della stella delle streaming IShowSpeed. Da figure ibride come Kai Cenat e KSI, alle incursioni comiche di Snoop Dogg. Da personaggi mezzi musicisti e mezzi streamer alla Diego Naska, ai video di Shiva col tiktoker Rimoldigno.
Un allargamento di prospettiva che ci può aiutare a riscrivere i contorni della figura del talent musicale oggi. E che risponde, in qualche modo, a più esigenze.
La prima, assimilabile a quella dei creatori digitali, è quella di costruire una comunità di affezionati al di là del confine musicale e discografico, ampliando il proprio target e rendendosi appetibili, se necessario, per nuove opportunità commerciali — nuovi cereali, nuovi energy drink, nuove partnership d’ogni sorta.
Seconda, l’urgenza di adattarsi alle abitudini del pubblico, in un mondo in cui musica e content vivono indistintamente sulle stesse piattaforme, e dove il nostro attention span — il tempo che prestiamo a un contenuto prima di decidere se continuare a seguirlo o meno — si è assottigliato a una manciata di secondi.
In questo senso, un singolo, un audiolibro o un reel di Fedez comincerebbero pian piano a somigliarsi nel modo in cui occupano le nostre giornate e il nostro tempo libero, diventando competitivi nel momento in cui scegliamo cosa consumare nella nostra personalissima dieta mediatica, e portando alcuni rapper, in buona sostanza, a muoversi sui nostri schermi come fossero dei content creator. Su più livelli.
L’altro giorno, su YouTube, mi sono imbattuto per caso nel videoclip di un trapper milanese, abbastanza noto soprattutto fra i più giovani. È uscito due o tre mesi fa, e ha ben più di cinque milioni di visualizzazioni: tantissime, nel modo in cui si contano i numeri online oggi. Eppure quasi scontate per il calibro dell’artista e per il tipo di canzone proposto: la cover di un brano degli anni Duemila, esercizio comune a molti e quasi doveroso al momento in cui è stata pubblicata la traccia.
Pubblicare nuova musica in assonanza con l’estetica del mese, mettendo in pausa la volontà di perseguire un percorso coerente, era ed è già da qualche tempo prassi consolidata nel mondo urban: usare The Weeknd come reference ideale, come celebrare il ritorno dei Duemila — appunto. Cantare sulla “cassa alla francese”, o preferirle un ritmo più drill, londinese, perché lo fanno tutti.
E così, pur avendo i crismi della hit — il ritornello che ti si fissa nel cranio, l’estetica giusta, le carte in regola per “restare” — di quella canzone non ricordavo più neanche l’esistenza. Era stata seguita a breve termine da altri singoli dello stesso artista, e lasciata poi indietro di un paio di posti sui suoi relativi canali. Come un meme usurato dal tempo: una battuta che, passata di moda, non fa più ridere.
Intendiamoci: mentre scrivo probabilmente migliaia di adolescenti ne staranno urlando il ritornello negli schiuma party d’Italia. Ma a colpirmi, in qualche modo, era la scelta di puntare sulla formula vincente, la cover perfettamente retrò, per poi passare alla pubblicazione di altri due singoli diversi e a stretto giro: la direzione musicale alla moda, e la frequenza nelle uscite. Un modo nuovo di comunicarsi, sicuramente diverso dalla discografia millennial alla quale siamo stati abituati: album ogni due o tre anni, un pugno di singoli, e una gravosissima stitichezza social.
In questo senso, un singolo, un audiolibro o un reel di Fedez comincerebbero pian piano a somigliarsi nel modo in cui occupano le nostre giornate e il nostro tempo libero, diventando competitivi nel momento in cui scegliamo cosa consumare nella nostra personalissima dieta mediatica.
In qualche modo, magari sbagliando, ho pensato a quanto questo modello stia diventando una regola, e immediatamente a quei creator che inseguono i trend contenutistici del momento perché tutti ne parlano: la chiave di ricerca più digitata, il tema che indicizza meglio su YouTube, il filtro di Instagram che cattura più visualizzazioni.
Come se adattarsi al genere del momento, a costo di produrre un lungo elenco di canzoni in pochi mesi, fosse assimilabile allo stesso sforzo in cui i creator si producono per restare nei “Per te” di TikTok, per essere rilevanti. Forse lo stesso meccanismo che porta gli youtuber a pubblicare un vlog sulla cronaca perché il true crime sta tirando, o a fare un video col salumiere virale per alzare l’engagement.
A lanciare una canzone in stile dembow, perché è quello che si aspetta un certo pubblico — e non che non ci sia arte anche nella composizione progettuale di un lancio marketing, o in un brano che si adatta ai gusti del momento. È che tutto pare essere sempre più frequente, costante, proprio come la produzione di contenuti per i social network.
Non a caso, per stessa ammissione di diversi artisti, prendersi del tempo per scrivere, per far respirare le uscite e per dedicarsi a una progettualità più ampia, starebbe cominciando a diventare quasi un lusso, un’operazione per pochi pesi massimi.
Così, con sempre maggiore frequenza, le nuove uscite affollano le library musicali di venerdì in venerdì — il giorno in cui quasi tutti “escono” — fuori da vecchie logiche. Come se si adattassero all’urgenza di metriche nuove, più “di piattaforma” che artistiche: tenere attivo un profilo, badare al conteggio delle stream, mostrare ai propri utenti che si è ancora “vivi”. Quasi come rispondessero alla domanda dei propri follower.
A ben vedere, nell’universo della content creation, è abbastanza comune garantire una simile costanza nelle pubblicazioni: per migliorare le performance dei propri prodotti, e per rispondere a una richiesta che non sembra mai sazia. «Vogliamo più video», «Non posti mai», «Sei scomparso», si legge spesso nei commenti: una sorta di ricatto morale che talvolta obbliga i produttori di contenuti a inventarsi qualcosa purchessia, e a tenere alto il numero delle uscite per non deludere la community.
Similmente, nell’universo urban di oggi è possibile che un artista scelga volutamente di pubblicare un brano quasi ogni settimana, o di uscire con due album nello stesso anno. Di apparire in varie collaborazioni, o di inventarsi delle versioni estese dei propri dischi già editi (le deluxe edition) per presidiare costantemente il mercato. Come se altrimenti si venisse — come youtuber, streamer o tiktoker — penalizzati, deindicizzati dalla piattaforma.
Una delle conseguenze di questa offerta spropositata è che i rapper, in un certo senso, sono sempre più costretti a costruire un proprio immaginario forte, univoco, trovare il proprio racconto, il proprio content: sia esso un album concettuale a tema cinema o letteratura, una escursione negli anni Ottanta o nella vita “di provincia”. Il calcio, o addirittura un colore.
In questa epica personale, sui magazine specialistici lo spazio per la critica si è fatto esiguo, e i momenti di riflessione sulla scena quasi nulli.
È pur vero che, a ondate, appaiono decine di approfondimenti in cui lo storytelling che l’artista ha deciso di proporre per quella stagione viene declinato sotto forma di breve documentario, un altro tassello contenutistico all’interno di un più vasto piano di lancio. Molto più facilmente, però, si possono trovare contenuti in cui se ne celebra la grandezza, in cui si contano dischi d’oro e di platino — così come tiktoker e youtuber contano le visualizzazioni, e gli streamer salutano i nuovi iscritti al canale. Come le Charlie D’Amelio del mondo guardano ai “mi piace” e all’engagement rate per ogni post.
In questa continua ricerca di una formula che consenta loro di apparire su più smartphone possibili e diventare virali, sono ormai diversi gli artisti rap che sfruttano il palcoscenico dei loro live per offrire qualcosa di notiziabile, di adatto a stories e reel.
E in un contesto in cui i concerti diventano sempre più “esperienza” che “esibizione canora”, ci si imbatte in continuazione sui social in decine di apparizioni sul palco “a sorpresa”, di ingressi “incredibili” in cui si appare addirittura da dentro una bara, o si arriva a ballare in dieci per tutta la durata del pezzo, o in cui si lancia l’acqua dalle bottiglie sul pubblico.
Degli stunt in favore di migliaia di videocamere, e un’ennesima occasione per creare content, che su TikTok — in particolar modo — circolano per giorni e vengono spesso indicati come “epici”, “straordinari”, rendendo a volte indistinguibile, scroll dopo scroll, la differenza fra chi fa musica e chi la balla in favore di camera.
Fatto questo lungo parallelo, magari spurio e un po’ sfacciato, mi chiedo se alla fine non si possa pensare a buona parte di rapper e trapper di nuova scuola, semplicemente, come ai primi artisti a dover convivere con le nuove piattaforme social, oggi prettamente performative: i primi a dover fare i conti con le esigenze di certi algoritmi, e con le necessità di un pubblico bersagliato da una costante e infinita offerta contenutistica. I primi a dover sgomitare per catturare l’attenzione che rivolgiamo ai nostri schermi.
Mi chiedo, insomma, se è così che possiamo spiegarci l’anomalia della musica urban, senza arrivare a scrivere un quarto articolo: la coesistenza dentro e fuori il palazzo, la realness e lo smaliziato rapporto con il marketing. Il legame con una generazione che ha nella musica — secondo vari studi — il suo interesse principale, ma che ha imparato a parlare la lingua della creator economy prima di noi. O almeno, sicuramente prima di me.