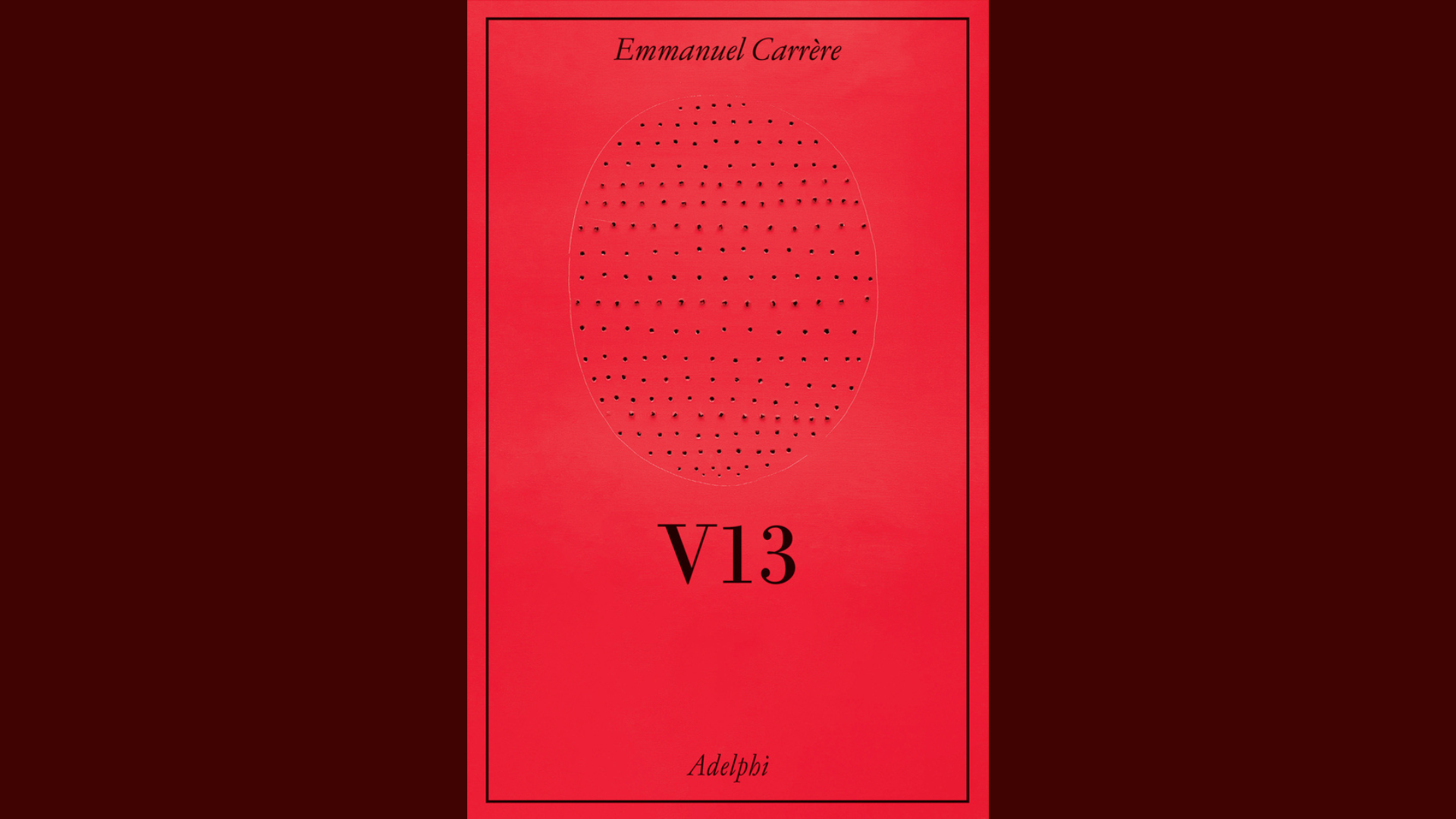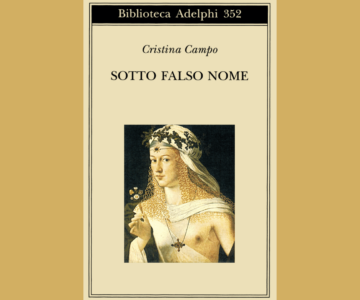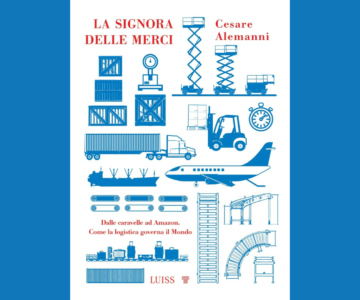V13 (Adelphi, 2023), l’ultimo libro di Emmanuel Carrère che racconta il processo seguito agli attentati parigini del 2015, fresco vincitore del Premio Strega Europeo, è come sempre con lo scrittore francese un’immersione negli abissi dell’animo umano e una grande prova di talento letterario. Ma questa volta c’è anche qualcosa di diverso.
da Quants numero 3, giugno 2023
Una notte d’orrore, una notte che ha ferito l’immagine del divertimento, colpendo simultaneamente un locale da concerti, dei ristoranti, dei bar e uno stadio — almeno quest’ultimo, forse per grazia, senza successo. Una trinità del tempo libero sociale — musica, mangiare e bere, sport — infranta dagli attentati simultanei di venerdì 13 novembre 2015 a Parigi. Quella che è diventata tristemente nota come “la strage del Bataclan”, avvenuta durante un concerto degli Eagles of Death Metal, è stata una mezz’ora di sangue che in sei sedi diverse ha causato 130 morti e quasi 400 feriti. Chiunque fosse in giro quella sera a divertirsi difficilmente si è dimenticato cosa stava facendo, mentre per chi era a casa, praticamente in diretta, arrivò lo shock di un altro colpo messo a segno dal terrore nel cuore dell’Europa.
Tornarci in mezzo con lo sguardo di Emmanuel Carrère nel suo ultimo libro V13, pubblicato per Adelphi, che ricostruisce gli eventi seguendo il processo dedicato agli attentati, è un’esperienza unica sia per la ricostruzione della tragedia, sia per capire le qualità di uno dei più grandi scrittori francesi viventi. La letteratura, per mano di Carrère, conferma la sua forza unica nel saper dare un altro tempo alla velocità con cui oggi, nell’orizzonte mediatico, si presenta la realtà. Lo fa rivolgendo il suo «strano desiderio» di scrittore verso un’altra operazione fuori registro, il processo «enorme» e «inedito» dedicato a quel “Venerdì 13”, che definisce come una «réclame formato gigante della giustizia» e che avrà i tempi di una gestazione, dall’8 settembre 2021 al 29 giugno 2022: nove mesi.
La letteratura, per mano di Carrère, conferma la sua forza unica nel saper dare un altro tempo alla velocità con cui oggi, nell’orizzonte mediatico, si presenta la realtà.
Carrère, reduce esausto dai fasti di Yoga, si propone al settimanale «Obs» per dei reportage: al secondo incarico decide di indossare i panni del cronista di giudiziaria e seguire i lavori del tribunale di Parigi dedicati al caso. Il processo in avvio è al centro di un’attenzione mediatica notevole, ma l’autore, come spesso sa fare, gioca un’altra carta, quella della costanza ossessiva sul suo argomento: «Altri si sono ripromessi di venire ogni giorno, di vivere i momenti morti come quelli salienti. Io sono uno di questi. Riuscirò a resistere?». La resistenza diventa un percorso di formazione d’animo e morale, di riflessione sulla giustizia come teatro e sul diritto, sulle vittime e sulla gestione collettiva del lutto, sull’origine e la radicalizzazione degli attentatori.
A monte, nel mettere Carrère nella posizione di Carrère, in un gioco tra autore e immagine dell’autore che gli riesce magico — e che infastidisce i suoi detrattori —, c’è sempre una certa dose di gioco e sfida. Sono termini vicini, quasi sinonimi, ma il primo è più ingenuo e curioso, il secondo vuole più esperienza e tecnica. Fin dal principio, è inconsueto il modo in cui Carrère si appresta alla cronaca giudiziaria: se la sfida sta nel come raccontare la complessa e ripetitiva macchina processuale che cerca di «trasformare l’emotività in diritto», il trauma in pena, il gioco è nella cadenza settimanale per i lettori del francese «Obs» (e in Italia per «La Repubblica») e nelle misure fisse, circa quattro cartelle per articolo. Una disciplina che lo costringe a scegliere praticamente in diretta il materiale da trattare e a ragionare implicitamente, settimana dopo settimana, sulla sequenza dei pezzi che va pubblicando. Il processo “V13”, come dice più volte l’autore, ha già la struttura di un romanzo, diviso com’è per capitoli dedicati a ogni aspetto della tragedia: una divisione che si riflette solo in parte nella tripartizione del libro tra “Le vittime”, “Gli imputati”, “La corte”.
Nel mandare poi il libro in stampa, Carrère aggiunge un terzo in più di materiale inedito e da quella sorta di feuletton della realtà, intinto di cronaca giudiziaria — genere a sé del giornalismo che l’autore omaggia e rispetta —, esce qualcosa di diverso e più incisivo.
Nelle prime sette settimane, per due ascolta la ricostruzione da parte delle forze dell’ordine, e per cinque le testimonianze dei superstiti e dei parenti delle vittime. Questi sono solo una parte delle circa duemilaquattrocento parti civili costituitesi contro gli imputati: quattordici i presenti, di cui undici rinchiusi in un box di vetro, tra cui Mohamed Abrini, complice senza parteciparvi di due attentati, e Salah Abdeslam, unico attentatore sopravvissuto che non si è fatto esplodere e ha disinnescato la sua cintura da kamikaze. Sono quasi trecento le testimonianze, tutte a ripercorrere quella notte, e hanno un effetto destabilizzante. Si va dai momenti in cui confessa che: «Non ce la facciamo più. Troppa sofferenza, troppo orrore», al riconoscimento che quanto sta avvenendo è unico: «Non sono fatti che si elencano e si esauriscono, ma voci che si esprimono, e tutte — insomma, quasi tutte — suonano esatte. Quasi tutte hanno l’accento della verità. Ecco perché questa lunga serie di testimonianze non è soltanto terribile ma magnifica».
Di questa magnificenza, e del fatto che queste giovani vittime sopravvissute siano da considerare eroi, Carrère con il suo infallibile intuito da narratore porta in pagina diversi esempi. Ci sono Alice e Aristide, fratello e sorella, atleti feriti pesantemente in qualche modo tornati a una vita attiva; Guillaume, che mentre altri venivano ammazzati per una parola viene chiamato sul palco del Bataclan da uno degli attentatori; Clarisse che ripensando a un film di James Bond ha guidato decine di persone a nascondersi in un sottotetto. Eroi per caso, che non avrebbero mai voluto esserlo. Storie a loro modo uniche, anche per la capacità umana di ricominciare, ambientate tra assassini che sparavano e sembravano divertirsi, voci sopravvissute a una notte di morte.
La resistenza diventa un percorso di formazione d’animo e morale, di riflessione sulla giustizia come teatro e sul diritto, sulle vittime e sulla gestione collettiva del lutto, sull’origine e la radicalizzazione degli attentatori.
Tutti i momenti dedicati alla carneficina sono impressionanti, crudi e diretti, per quanto il linguaggio degli investigatori e dei sopravvissuti cerchi se non di normalizzarli — è impossibile —, almeno di tradurli. La sensazione di tanti rimasti vivi al Bataclan di ritrovarsi al buio tra lampi di spari in mezzo a una strana melma, per poi capire che era di corpi ed ossa, si appiccica indelebilmente alla memoria del lettore.
A segnare un punto di svolta tra le testimonianze è una figura femminile: Nadia Mondeguer, di cui l’autore diventa amico e a cui dedica il libro. Nadia, di origini arabe, al ristorante La Belle Équipe ha perso sua figlia Monia, suo marito poi è stato tra i più attivi nel coordinamento dei sopravvissuti e a un certo punto, come per stanchezza, è morto. Nadia nel suo modo di chiedere ai terroristi da dove sia arrivato il loro gesto, è l’unica che riesce ad aprire una fessura attraverso cui, in un’atmosfera pesantissima, passa un filo di luce tra vittime e imputati.
A questi ultimi, Carrère lungo il processo dedica profili approfonditi, cercando di capire il momento della radicalizzazione rispetto alle loro vite di ventenni nati nella belga Molenbeek, nella regione di Bruxelles: «Sono cresciuti insieme, andati a scuola insieme, hanno fatto cazzate insieme, ed erano cazzate innocenti sinché nel 2012 non è sorta all’orizzonte la grande e tenebrosa e magnetica cazzata che ha stravolto le loro vite». Si tratta dell’Isis, del Califfato, dello Sham, nome islamico per la Siria in guerra, in cui si fa strada l’esercito estremista musulmano con una propaganda improntata al sadismo che attrae adepti da ogni dove. Tra questi, ci sono gli attentatori, addestrati in Siria tra i foreign fighters, invitati dall’amico e mente degli attentati Abaaoud — ucciso il 18 novembre 2015 dalla polizia — che, come riferisce Carrère citando la moglie di un combattente, si comportavano come «un gruppo di amici che massacra e decapita in un’allegra atmosfera da villaggio turistico».
Carrère sceglie i dettagli con cui raccontare il male e l’orrore con una naturalezza che maschera la precisione di un chirurgo della scrittura. Non sono studiati effetti retorici che vanno a vuoto, ma punctum — come per Roland Barthes quando scrive della fotografia, momenti d’attrazione e scintille — nella pagina. Tra questi, nel magma dei dati del processo, certi numeri inchiodano continuamente il lettore: i 542 faldoni dell’istruttoria, i 5,9 euro prelevati da ogni contratto assicurativo che costituiscono il Fondo di garanzia per le vittime del terrorismo, la telefonata numero 2476 fatta da Sonia, che oggi vive sotto copertura, al numero verde istituito dopo gli attentati, che ha permesso di catturare Salah Abdeslam, il calibro 7,62, utilizzato nella strage, che «provoca ferite devastanti, con crani esplosi e grandi fracassi facciali».
Carrère sceglie i dettagli con cui raccontare il male e l’orrore con una naturalezza che maschera la precisione di un chirurgo della scrittura. Non sono studiati effetti retorici che vanno a vuoto, ma punctum — come per Roland Barthes quando scrive della fotografia, momenti d’attrazione e scintille — nella pagina.
Se i dettagli colpiscono per strada, Carrére organizza simbolicamente l’orizzonte narrativo intorno a dei punti cardinali che usa per accompagnare se stesso nel procedere del racconto, svelando idee e ambizioni di quanto va scrivendo. Scopre le sue carte e le guarda insieme al lettore, alcune arrivano dalla realtà, altre dalla cultura.
Se dalle vittime coglie il desiderio che il processo, e a seguire il suo libro, siano «un racconto collettivo», dei terroristi fa sua una frase di Salah Abdeslam: «Tutto quel che dite su noi jihadisti, è come se leggeste l’ultima pagina di un libro. Il libro dovreste leggerlo dall’inizio». Questi due input si bilanciano poi con i pochi e fondamentali autori che cita per orientare la tensione morale e stilistica del suo affresco: Truman Capote di A sangue freddo (1966), capostipite del non fiction novel nato da un caso di nera, Simone Weil e Spinoza. Di quest’ultimo, è centrale il precetto: «Non deridere, non compiangere, non condannare, comprendere soltanto». Carrère ci riesce cambiando il suo modo di essere Carrère, con uno slittamento di prospettiva rispetto al modo in cui il lettore è abituato a incontrarlo. L’autore ha una certa confidenza con i temi difficili: da L’avversario (2000), in cui ricostruiva la storia del bugiardo e assassino Jean-Claude Romand, a Vite che non sono la mia (2009), in cui affrontava il lutto di chi perde un figlio. Sono entrambe vicende in cui entra in prima persona, non solo da osservatore, ma da mediatore del male attraverso il proprio Io — una posizione ingombrante che rende riconoscibile e non banale anche grazie a una felicità di scrittura rara. Quell’Io di Carrère e l’uso che fa del proprio privato, in una lunga tradizione francese che passa da Montaigne e Rousseau, è tanto affascinante per molti, quanto criticabile per i detrattori — anche per vie legali, come l’ex-moglie che l’ha costretto a rivedere Yoga (2020) prima della pubblicazione. Questa volta Carrère sceglie un’altra posizione: è più distante, il suo io è meno invadente, ma la sua interiorità non è assente, ha un nuovo ruolo, verrebbe da dire, civile.
Centrando le sue ambizioni, scrive così la cronaca di come si cura una grande ferita collettiva e di come una società democratica occidentale elabora un trauma. È bello, terrificante e avvincente, quindi sublime, e per una volta Carrère abbandona se stesso per raccontare solo l’altro. Lo fa perché ci riguarda e perché ha capito anche in questa occasione, rispetto alla tragedia, il suo ruolo.