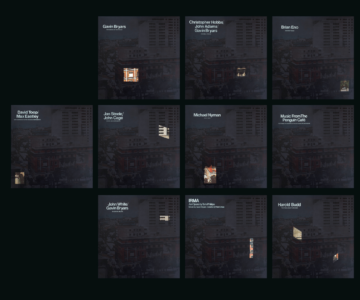Pubblichiamo, per gentile concessione di Blackie Edizioni, tre capitoli di Vestiti Musica Ragazzi (2023) nella traduzione di Paola De Angelis.
A metà degli anni Settanta Viv Albertine voleva a tutti i costi far parte di una band. Ma non sapeva suonare una nota, e non conosceva nessuna ragazza che facesse musica a Londra. Un paio d’anni dopo entrava nelle Slits, una delle prime e più influenti punk band al femminile. Questo è il suo racconto di quegli anni che hanno cambiato ogni cosa: una battaglia a colpi di eccessi e provocazioni, droga, sesso, look incredibili, “gang femministe” e disadattati di talento.
da Quants numero 3, giugno 2023
1975, Il salto
«Stasera il nuovo gruppo di Malcolm suona alla Scuola d’Arte di Chelsea, venite?» chiede Rory. «Sì» rispondo io.«No» dice Mick.Mick sa già dei Sex Pistols. È amico di Glen Matlock, il bassista, ma sono suoi rivali. Dice che quella sera ha le prove con il suo gruppo, perciò non può andare a sentire altre band. Cerca di farmi cambiare idea, ma non ci riesce. A me sembrano interessanti. I Pistols suonano nell’aula magna della scuola. È una sala qualsiasi, con il pavimento di legno, il palco con un sipario logoro di seta verde tirato di lato sul fondo, il soffitto a volta con le colonne di metallo e alte pile di sedie di plastica grigie appoggiate ai muri. C’è odore di cera per pavimenti. Poche persone tra il pubblico, giusto qualche gruppetto sparso qua e là ai lati della sala. Un tizio dall’aria impertinente, con addosso una giacca azzurro cipria e riccioli arancione chiaro che gli ricadono sulla fronte, viene verso di noi. «Ecco Malcolm» dice Rory.Malcolm McLaren sembra un po’ più grande degli altri ed è vestito meglio, si vede che ha qualche soldo in tasca. Rory ci presenta. Malcolm è socievole e affascinante senza dare l’idea di provarci, sembra contento di vedere un’altra persona al concerto. Si vede che pensa: Bene. L’altra volta c’erano dieci persone, stavolta sono undici. Ha un’espressione molto aperta, non giudicante, e uno sguardo divertito. Non mi squadra su e giù per vedere come sono vestita, come mi sarei aspettata dal proprietario di una boutique. Quando Malcolm mi sfiora la mano, penso: Sono vestita nel modo sbagliato, del colore sbagliato, nel posto sbagliato. Lo penso nell’attimo in cui ci tocchiamo. Porto un giubbotto aderente di pelle marrone, un modello da bambino, del genere che avrebbe indossato Marc Bolan, stivali di pelle celesti fatti a mano e jeans. I capelli me li ha tagliati e colorati Keith da Smile a Knightsbridge, molto biondi sopra e molto scuri sotto. Capisco che è tutto sbagliato. Sono mortificata. Ero fichissima al Dingwalls, sono fichissima a Hammersmith, non lo sono per niente qui. Do uno sguardo in giro per vedere come sono vestiti gli altri. Di nero.
I Sex Pistols salgono sul palco. Sono rumorosi e turbolenti, ma non sono dei cattivi musicisti. Ho già visto altri gruppi con lo stesso atteggiamento anarchico: i Pink Fairies, i Pretty Things, la Edgar Broughton Band. Quello che spicca è il cantante: sul palco, davanti agli altri, Johnny Rotten è chino sull’asta del microfono. È così inclinato in avanti che rischia di capitombolare nello spazio vuoto tra il palco e gli spettatori. Ha la faccia pallida, il corpo si contorce e assume pose così brutte e goffe da sembrare deforme. Non si mette a ballare per intrattenerci, non fa nessun tentativo per piacere al pubblico. È uno qualsiasi, più o meno della nostra stessa età, il genere di ragazzo che veniva alle medie con me. Non è una star appariscente come Marc Bolan o David Bowie, agghindata con costumi esotici, né un virtuoso della chitarra come Eric Clapton o Peter Green. Non è nemmeno uno di quei cantanti virili dei gruppi rock and roll che si esibiscono nei pub: è solo un tizio di Finsbury Park piuttosto incazzato. Johnny ci prende in giro con il suo accento di Londra Nord, non ha studiato canto, non è intonato, ha una voce piagnucolosa e strascicata, distaccata. Canta senza emozione e senza nemmeno quell’inflessione nasale finto americana. Tutte le cose che per me sono imbarazzanti, lui le trasforma in virtù. Non si scusa per quello che è e per il posto da cui proviene, anzi ne è orgoglioso. Se il mondo non prova interesse per lui, non è colpa sua, non significa che lui non ne è degno. Lo guardo mentre si contorce e ulula sul palco e mi rendo conto che sono gli altri a essere sbagliati, non lui. Come è riuscito quel ragazzo delle case popolari, che ha studiato alle scuole pubbliche, privo di un’educazione musicale, a compiere il salto mentale che gli ha permesso di diventare il leader di un gruppo e salire su un palco? È coraggioso, rivoluzionario e manda un messaggio molto forte, il più potente che si possa mai trasmettere: sii te stesso.
Avevo sempre pensato che le circostanze della mia vita – povera, di Londra Nord, scuola pubblica, casa popolare, femmina – non mi avessero equipaggiata per il successo. Mentre guardo i Sex Pistols, capisco che per la prima volta non ci sono barriere tra me e il gruppo.
Avevo sempre pensato che le circostanze della mia vita – povera, di Londra Nord, scuola pubblica, casa popolare, femmina – non mi avessero equipaggiata per il successo. Mentre guardo i Sex Pistols, capisco che per la prima volta non ci sono barriere tra me e il gruppo. Le idee che mi ronzano nella testa da anni improvvisamente si fanno nitide e pressanti. John Lennon, Yoko Ono, i Kinks, la ragazza (?) nella Third Ear Band, quella che si improvvisa percussionista nei Kokomo, Sandie Shaw, Suzi Quatro, Emma Peel, le due ragazze della Incredible String Band, Patti Smith, Mick Jones, Johnny Rotten, la mia passione per la musica… È fatta. Finalmente vedo non solo l’universo di cui ho sempre voluto far parte, ma anche il ponte da attraversare per arrivarci.
1977, Daventry Street
Sto per suonare con le Slits e ho l’ansia, perché provare con Sid nei Flowers of Romance è stato snervante. La sala prove è in uno squat in Daventry Street, Londra Ovest. Le pareti sono rivestite di cartoni delle uova, in un angolo è appoggiato un materasso puzzolente e ammuffito, un timido tentativo di attutire il rumore; il pavimento è ricoperto da una vecchia moquette strappata, su cui troneggiano due amplificatori e una batteria. La grancassa di Palmolive è ancorata a terra con un paio di mattoni avvolti in un vecchio asciugamano. Kate Korus, la chitarrista delle Slits, non c’è. Non ho chiesto io di non farla venire, ma sono contenta: c’è una possibilità che io possa andare bene per il gruppo e comincio a pensare che la cosa mi farebbe piacere. Non ho idea di come andrà questa prova o jam session. Ho visto le Slits suonare e so che musicalmente non sono delle virtuose, ma per me è difficile lo stesso perché suono la chitarra da poco tempo. Dico al gruppo che non sono molto brava e che non so improvvisare. Loro mi rispondono in coro: «Nemmeno noi, va bene così». Mi sento più tranquilla e tiro fuori la Les Paul Junior dalla custodia di cartone. Ari è l’unica ad avere una formazione musicale, è arrivata al sesto anno di pianoforte. Mi insegna gli accordi di una canzone che hanno scritto, “Let’s Do the Split”. Riesco a malapena a tenere le dita sui tasti mentre la svisceriamo un po’ di volte. Non sembrano inorridite dal mio modo di suonare, anzi loro sbagliano quanto me e io inizio a rilassarmi. Mi chiedono se ho una canzone. Ho solo un riff di chitarra e qualche verso ispirato da una conversazione al telefono con Johnny Rotten a proposito di Sid, un paio di settimane prima. Si intitola “So Tough”. Suono il riff e a loro piace un sacco, faccio vedere le parole scritte nel mio libricino dei testi e gli piacciono anche quelle. Cominciamo a lavorare sulla canzone ed è in quel momento che le cose si mettono davvero in moto. Fra me e Ari c’è un’intesa creativa: abbiamo un rispetto reciproco per le nostre idee, accettiamo con facilità l’una i suggerimenti dell’altra, senza problemi di ego, abbiamo la stessa sensibilità. Ci piacciono gli stessi suoni, ci capiamo e ci stimoliamo a vicenda. Dopo l’esperienza con Sid, so che riuscire a scrivere con qualcuno sentendosi a proprio agio è una cosa rara e preziosa. La canzone prende forma e suona bene. Proprio come l’avevo immaginata, ma meglio.
Voglio che i ragazzi vengano a sentirci suonare e pensino: Voglio far parte di quel gruppo, e non Sono carine o Me le vorrei scopare, ma Voglio far parte di quella band, appartenere alla loro tribù.
Dopo le prove mi sento avvolgere da una sensazione di calore, come quando hai creato qualcosa: un misto tra la soddisfazione per un lavoro fatto bene e il benessere dopo aver fatto stretching. Ci sediamo per terra con le spalle appoggiate agli amplificatori – Palmolive con i gomiti sul rullante, protesa verso di noi – e ce ne stiamo a chiacchierare e ridere. Mi dicono che quando il giorno prima ho telefonato a casa di Nora, dopo che Ari ha riattaccato sono scoppiate tutte a ridere e hanno detto: «Ah, adesso le interessa suonare con noi!». Ci spostiamo nella cucina gelida e ci stringiamo intorno alla stufa. Osservo le ragazze mentre beviamo il tè dalle tazze incrinate e macchiate: Palmolive con quello sguardo fulgido da spagnola, il corpo tonico e abbronzato e il viso stupendo a forma di cuore, incorniciato dai capelli ramati tagliati corti. Tessa, la pelle bianca come la neve, i capelli neri come le ali di un corvo e gli occhi azzurri: sembra una giovane Elizabeth Taylor vestita da maschio. Ari, con i capelli lunghi arruffati, la bocca carnosa, i grandi occhi blu sempre sbarrati, una spruzzata di lentiggini, totalmente inconsapevole della sua bellezza, una Lolita incrociata con Minnie the Minx. Sono tutte stupende e interessanti, perché non me ne sono accorta prima? Sono fantastiche. Voglio che i ragazzi vengano a sentirci suonare e pensino: Voglio far parte di quel gruppo, e non Sono carine o Me le vorrei scopare, ma Voglio far parte di quella band, appartenere alla loro tribù. Voglio che i ragazzi desiderino essere noi, non che se ne escano con il solito commento, come mi è capitato l’altra sera a una festa a Islington, quando un tizio mi ha detto che suonava la chitarra. «Anch’io suono la chitarra», ho commentato. «Grande! Nel nostro gruppo ci starebbe proprio bene una bella gnocca.» Era Paul Weller. Quando gliel’ho raccontato, Mick voleva picchiarlo, ma io gliel’ho impedito perché così sarei sembrata debole. Secondo me i vestiti delle Slits sono abbastanza cool, il nostro atteggiamento è abbastanza ribelle e la nostra musica è così strana e potente che potremmo riuscire a cambiare una volta per tutte quel genere di atteggiamento maschilista. Siamo tutte eccitate e cominciamo a sistemarci i capelli a vicenda. Io cotono i capelli a tutte per farli assomigliare ai miei, ma senza averne l’intenzione, succede e basta. Ci mettiamo davanti a un vecchio specchio rotto e fissiamo il nostro riflesso. È fatta: sembriamo una vera band.
2008, Le nuove Slits
Il mio unico desiderio è riuscire a cantare e suonare tre canzoni a un livello decente senza scendere mai al di sotto, a prescindere dalla stanchezza e dalla qualità del sistema di amplificazione del locale. Al momento oscillo tra il passabile e il totalmente atroce, per cui mi sembra un’aspirazione impossibile. Nelson è impegnato con la sua vita e non può continuare a venire alle serate Open Mic con me: il pensiero di andare nei locali da sola due volte a settimana mi terrorizza. Per una donna entrare in un pub – alcuni dei quali sono punti di sosta per camionisti – nel mezzo del niente è già di per sé una cosa piuttosto audace, ma salire su un palco e cantare le tue canzoni assurde mentre tutti gli altri fanno cover di “Chasing Cars” è una follia pura. Siccome crede in me e vuole essere sicura che io non molli, la mia amica Traci prende il treno da Londra ogni volta che vado a suonare. La vado ad aspettare a Brighton, Hastings o alla stazione più vicina al pub dove suono quella sera, lei si siede accanto a me mentre aspetto il mio turno e poi ce la ridiamo insieme quando ho finito. È una vera amica.
Comincia a piacermi il contrasto tra quello che il pubblico si aspetta da una donna piacente e quello che io gli do: parole piene di rabbia e note affilate di chitarra.
Sono diventata più coraggiosa, provo canzoni diverse, parlo con il pubblico, faccio battute. Quando suono in un pub di Lewes, nel Sussex, un tizio di nome Tom Muggeridge mi si avvicina per dirmi che le mie canzoni gli piacciono molto e mi chiede se mi va di suonare a un festival che sta organizzando all’Arts Lab di Lewes due mesi dopo. Il mio primo concerto. Metto insieme un gruppo con Tom al basso e con un batterista e un violinista di Brighton che ho conosciuto durante le mie spedizioni. Facciamo un paio di prove in un magazzino. La sera del concerto alcune cose non funzionano, ma è un enorme passo avanti; mentre sono sul palco mi rendo conto che adesso sono io la cantante. Sono passata dal ruolo di chitarrista a quello di leader del gruppo, un salto enorme per qualsiasi musicista in una band: se cominci come strumentista, non credi di avere le qualità per diventare quella che sta davanti agli altri. Non mi faccio più prendere in giro quando suono. Una sera davanti a un pubblico di vecchi rocker vocianti con la coda di cavallo ho gridato: «C’è qualcun altro qui che ha provato l’eroina o fatto un disco?». C’è stato un silenzio stupito. «Io sì, perciò chiudete la bocca oppure andate a casa a lucidare le vostre chitarre.» (Avevano tutti delle chitarre perfette, nuove di zecca e si vedeva benissimo che le tiravano fuori dalla custodia una volta a settimana, le lucidavano e poi le rimettevano a posto.) Non accetto neanche più che il tecnico mi dica che ci sono troppi alti. «Deve avere un suono sgradevole» gli dico girando ancora di più la manopola e sperando che gli spacchi le orecchie. Comincia a piacermi il contrasto tra quello che il pubblico si aspetta da una donna piacente e quello che io gli do: parole piene di rabbia e note affilate di chitarra. Dopo un anno e mezzo di serate Open Mic, mi ritrovo in un grande pub moderno e senza anima di Brighton con il barbecue all’aperto e un cocktail bar. Canto la prima canzone mettendoci tutta me stessa, ma non se ne accorge nessuno, continuano a ridere, parlare e strillare. Sono stufa, io non faccio musica di sottofondo, così cambio le parole della canzone successiva in «Cazzo, coglioni, fica, merda, piscio, sega» e qualsiasi altra parolaccia che mi viene in mente, e continuo a ripeterle finché tra il pubblico scende il silenzio. Quando finalmente mi stanno a sentire, dico: «Grazie e buonanotte». È l’ultima serata del genere a cui partecipo.
Il concerto delle New Slits si avvicina e io non sono nervosa. Quello che ho fatto nei pub nell’ultimo anno, con la gente a pochi centimetri da me, suonando le mie canzoni da sola, è molto più terribile che trovarsi su un palco con un gruppo. Andiamo in Spagna ed è divertente stare con Ari e Tessa e ritrovare lo spirito di gruppo. Quando arriviamo in albergo, ci riuniamo nella stessa camera, a chiacchierare sdraiate sui letti. Non c’è un altro gruppo di donne al mondo con cui mi sono sentita più in sintonia che con Ari, Tessa e Palmolive (vorrei che ci fosse anche lei nella stanza con noi in quel momento), non solo per la nostra storia comune, ma perché siamo donne molto simili. Ari ci racconta dei problemi che sta passando in Giamaica, a Kingston girano voci che lei sia una spia della CIA e siccome qualcuno ci crede, vogliono ucciderla. Non so come faccia a sopportare la pressione costante che subisce da quando aveva quattordici anni, solo perché ha un aspetto un po’ diverso e perché fa quello che vuole senza compromessi. Mi chiede di controllare un bozzo che ha sul seno da circa un anno: sa che ho avuto il cancro e spera che le possa dare qualche buon consiglio e rassicurarla. Lo tocco leggermente, è piuttosto grosso, ha le dimensioni di una mandorla. Non ho idea se è una cisti o un tumore, perciò le dico di andare subito dal dottore appena torniamo in Inghilterra. Dice che non le piace l’Inghilterra e si farà controllare quando torna in Giamaica. Nel locale abbiamo un grande camerino con del cibo, sul palco ci sono i monitor così possiamo sentirci: è tutto un lusso per me. Mi piace suonare con altri musicisti, mi sento più protetta rispetto a quando suono da sola. Non mi sento molto a mio agio a suonare le canzoni del nostro repertorio: i brani originali delle Slits – anche se musicalmente superano la prova del tempo – non hanno più un impatto emotivo su di me adesso che ho scritto canzoni mie. I pezzi nuovi, che sono tutti influenzati dalla dancehall giamaicana, non mi risuonano musicalmente, anche se sono molto belli. Come musicista, le canzoni non mi dicono niente, preferirei stare in mezzo al pubblico a ballare e a divertirmi.
Il concerto successivo delle New Slits è a Manchester. Vado a prendere mia figlia da scuola così può assistere allo show. Riesco a vederla dal palco, seduta in prima fila, lo sguardo fisso su di me con un’espressione di evidente orgoglio, e capisco di aver fatto la cosa giusta anche secondo lei. Se un genitore riesce a vedere un’espressione del genere sul volto di suo figlio, anche una sola volta nella vita, è come trovare il Sacro Graal. Durante un momento dub del concerto suono un paio di accordi astratti e dissonanti sul ritmo, ma Ari si precipita da me e mi grida di smettere di suonare, li detesta. Mentre torniamo a Londra quella sera, guardando l’autostrada sfilare davanti ai miei occhi fuori dal finestrino della macchina, decido che non farò altre date con le New Slits, preferisco suonare la mia musica. La mia bambina dorme raggomitolata con la testa sul mio grembo, le accarezzo i capelli, provo un amore immenso per lei. Ripenso all’amore che provavo per le Slits venticinque anni fa e a come mi sono sentita devastata quando si sono sciolte, come una che è stata mollata dal fidanzato. Ho sofferto per anni, ma alla fine sono guarita e sono diventata più dura, con le mie cicatrici, perché dovevo farlo. Ari ci ha reso la vita impossibile come gruppo, poi anni dopo è ritornata, come fanno tanti amanti che ti hanno abbandonato, ma per me le cose dovevano funzionare allora, non adesso.