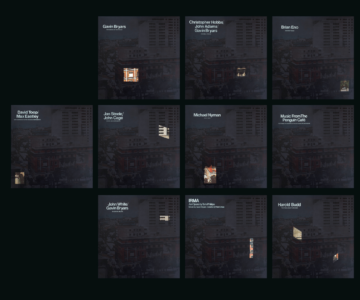Dai record di Squid Game all’Oscar di Parasite, passando per i successi dell’industria tecnologica, la Corea del Sud è sempre più al centro del mondo, e anche in Occidente il K-pop è qualcosa di più di una moda passeggera. Ecco come ha conquistato la musica, la moda e l’anima del pianeta.
da Quants numero 1, aprile 2023
Nel 2020 la musica dal vivo era data per morta. Con la speranza di generare profitto, nel mezzo della pandemia, qualcuno pensò di scommettere sui concerti in streaming. Convincere qualcuno a pagare per un live a distanza, però, sembrava impossibile. Finché il 14 giugno 756mila persone paganti in 107 paesi si sono collegate per assistere a un concerto dei BTS, la band coreana di maggior successo di sempre. Nessuna popstar occidentale è riuscita ad avvicinarsi a quella cifra, e prima che qualcuno ce la facesse i concerti sono fortunatamente tornati. Ma la supremazia commerciale di quel fenomeno musicale, ancora ignoto a molti, era stata certificata. Quell’anno, e l’anno successivo (e quasi certamente anche nel 2022), i BTS sarebbero stati incoronati dall’industria fonografica riunita (IFPI) come gli artisti più venduti e ascoltati al mondo. L’ondata coreana, arrivata di soppiatto come sottocultura globale, era emersa e si era infranta su tutti noi.
Nell’accezione più semplice, il K-pop è la musica leggera prodotta in Corea del Sud, cantata e danzata da artisti e (soprattutto) band di idol, ragazzi carini e spigliati che vengono raccolti e addestrati con un obiettivo semplice e ambizioso: farsi conoscere ovunque. La storia trentennale del K-pop ha accelerato vertiginosamente nello scorso decennio, quando tutte le classifiche (anche in Italia) si sono aperte al genere. Ma questo non è solo un racconto di canzoni: la K-wave, o hallyu, è un affare tecnologico, politico, di moda e di costume fin dal principio.
Nell’aprile del 1992 un ex cantante metal si presenta a un popolare talent show televisivo coreano con il suo nuovo progetto: Seo Taiji and Boys, un trio composto da un frontman e due ballerini che lo accompagnano. Il brano in gara, un rap sbarazzino intitolato “Nan Arayo”, viene stroncato dalla giuria. Eppure il singolo raggiunge il primo posto della classifica coreana e lo mantiene per 17 settimane. In un paese appena uscito dalla sua ultima fase di dittatura e censura culturale, la musica importata dall’America attecchisce presso dei giovani che non si riconoscono nella tradizione e per la prima volta sono liberi di dirlo. Con i soldi. La prima generazione del K-pop è pronta, ma un’industria dell’intrattenimento deve ancora nascere.
Ma questo non è solo un racconto di canzoni: la K-wave, o hallyu, è un affare tecnologico, politico, di moda e di costume fin dal principio.
Convinti che il contenuto non basti senza i giusti canali, i pionieri coreani cercano un’integrazione multimediale simile a quella che i primi gruppi di idol giapponesi già mettono in pratica da qualche anno, popolando le radio ma soprattutto le tv di Tokyo. Per questo in Corea si attinge alla medesima filosofia: crescere i talenti dal primo all’ultimo momento. L’archetipo è americano, e risale allo Studio System della vecchia Hollywood, e soprattutto alla fabbrica di hit della Motown Records di Berry Gordy, che aveva desegregato la musica pop.
Neppure boy band americane famose come i Backstreet Boys sono state coltivate con la cura che nel K-pop diventa presto pratica comune, una progettualità a 360° definita “cultural technology”. A coniare il sistema è Lee Soo-man, fondatore di SM Studio nel 1989 (poi SM Entertainment), che dei talenti intende seguire ogni interesse commerciale, per aumentarne efficacia e longevità. Non è un caso che siano proprio due artisti ad aprire tra il ‘96 e il ‘97 le agenzie/etichette che con SM andranno a comporre le “Big Three” del K-pop. Yang Hyun-suk, già componente dei Seo Taiji and Boys, e il cantante Park Jin-young, creano rispettivamente YG Entertainment e JYP Entertainment con la consapevolezza che senza un lavoro assiduo non si può durare. Per ottenere questo la vita dei cantanti deve somigliare a quella degli atleti più che a quella delle rockstar.
La selezione e l’addestramento dei progetti K-pop è importante quanto la produzione e il marketing successivi: vocalist (e poi rapper) e ballerini devono partire con tutte le doti necessarie per un successo immediato: tecnica, affabilità, fascino e personalità. Quindi è normale e previsto che gli artisti in crescita, o trainee, passino anni di preparazione nel cosiddetto dungeon, le “segrete” dell’etichetta, prima di debuttare. Dopo la selezione, magari in un reality televisivo del genere survival show, il training prevede lezioni di danza e canto, ma anche di lingue (mandarino, giapponese, inglese). Nel frattempo i particolari della loro immagine e talvolta anche della vita privata, dal trucco al vestiario, dalla dieta alle relazioni sentimentali, sono tenuti sotto osservazione. Per quanto spietato, talvolta considerato disumano, il sistema ottiene presto risultati storici. Già nel 2002 la solista BoA è prima nella chart giapponese: il secondo mercato musicale mondiale cede a un’industria che un decennio prima sostanzialmente non esisteva.
Tra il 2000 e il 2010 le Big Three (divenute Big Four con Big Hit, fondata nel 2005, e oggi nota come Hybe) mettono radici in Oriente e fanno capolino in America: in questo periodo debuttano i TVXQ, le Girls’ Generation, le f(X) e gli SHINee dalla scuderia SM; il solista Se7en e i Big Bang, di YG; il solista Rain e le Wonder Girls, di JYP. La chiave del loro successo non è tanto il pastiche di generi musicali, un bubblegum sonoro dove il contrasto tra rap ed EDM, rock e R&B produce gusti familiari eppure inediti. Semmai sono i video curatissimi, possibilmente molto colorati e accompagnati da balletti irresistibili, a competere (ancora da lontano) con il pop occidentale nella transizione dall’era di MTV a quella di YouTube. Gli idol sono disposti a fare quei mestieri che alle star americane interessano sempre meno: cantare in gruppo, applicarsi alla danza con dedizione militare, interpretare un’innocenza dei sentimenti che non si addice a un Occidente ben più cinico, comportarsi da ambasciatori e simboli di una cultura nazionale.
Il K-pop è una forma di soft power per la Corea del Sud. Un primo sostenitore politico di questa tesi è il presidente Kim Dae-jung, in carica dal 1998 al 2003, convinto che l’entertainment possa aiutare il paese a risollevarsi (moralmente ed economicamente) dopo il crack finanziario del 1997. Vent’anni dopo, l’indotto del K-pop sull’economia di Seoul è stimato tra i 10 e i 12,3 miliardi di dollari (2019). Contemporaneamente, alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang del 2018 la parata inaugurale delle delegazioni nazionali viene accompagnata da brani di BTS, Twice e Red Velvet: davanti al mondo la Corea e il K-pop sono una cosa sola.
C’è forse poi una funzione politica più profonda nel tripudio di ragazzi e ragazze che rappresentano i coreani nel mondo, ed è l’idea che nei giovani risieda la risorsa più importante di un paese. Il K-pop esprime fiducia nei giovani, la convinzione che le nuove generazioni (se ben indirizzate) siano la parte migliore della società. Di fronte allo sgretolarsi delle certezze e alle tensioni generazionali in Occidente, il futuro immaginato a Seoul non è una destinazione lontana, potenzialmente minacciosa, ma una visione affidata a chi quel futuro lo vivrà, possibilmente senza dimenticare certe tradizioni. Il K-pop, insomma, è una forma molto raffinata di ottimismo.
Le grandi agenzie concordano: i loro idol sono ragazzi e ragazze con la faccia pulita, rispettosi degli adulti, sgobboni e sognatori, che si tengono lontani dalle droghe. Il loro comportamento comunica forza, perseveranza e serenità, valori base della società coreana ai quali si affiancano i valori estetici occidentali nell’abbigliamento, nel sound e nel trucco. Devono essere simboli di apertura all’estero, certo, ma anche di osservanza delle convenzioni, cittadini modello che non si considerano esentati dai doveri civili. Come il servizio militare, obbligatorio per tutti i maschi coreani. Nemmeno i BTS, band che per risultati e influenza è paragonabile ai Beatles, possono sottrarsi alla leva, e perciò sono attualmente in pausa fino al 2025. Una scusa in più per avviare altre attività remunerative, come vedremo.
Gli idol sono disposti a fare quei mestieri che alle star americane interessano sempre meno: cantare in gruppo, applicarsi alla danza con dedizione militare, interpretare un’innocenza dei sentimenti che non si addice a un Occidente ben più cinico, comportarsi da ambasciatori e simboli di una cultura nazionale.
L’egemonia regionale nell’area est-asiatica è cosa fatta già all’inizio degli anni Dieci, quando il mercato cinese e quello giapponese si arrendono a band multilingue e multiculturali, come gli Exo. La K-wave non è più una conquista, ma una colonizzazione: i casting vastissimi pescano dalle comunità coreane nordamericane e dai mercati asiatici, mentre si costruiscono ad hoc sub-unit (cioè porzioni o versioni alternative di una band). La rete allarga ulteriormente l’ondata, permettendo ai fan di sentirsi agenti del successo dei loro favoriti, veri e propri coloni o evangelisti del K-pop. Dotati di un’alfabetizzazione digitale precoce, i gruppi organizzati diventano operazioni transnazionali per azioni collettive coordinate, gli apostoli del genere creano luoghi digitali di scambio di notizie e informazioni. Questi fandom sono pionieri nella creazione di contenuti dal basso: già dal 2002 il colosso digitale coreano Naver punta sullo “user generated”, YouTube prima di YouTube, e gli utenti interpretano per primi questa filosofia con particolare originalità. Come nel caso delle “fancam”, che vengono fatte risalire al 2010: piccoli montaggi amatoriali di un singolo idol, ripreso in un evento pubblico ma isolato dai suoi colleghi. Grazie al controllo garantito dal montaggio, le “fancam” prima e i più raffinati “edit” poi sono il K-pop in soggettiva, ma dove il punto di vista che comanda è quello dello spettatore, dove l’occhio che guarda è quasi più importante dell’oggetto guardato. L‘ondata è pronta a diventare tsunami.
Nell’estate del 2012 esce “Gangnam Style”, pezzo mezzo satirico mezzo furbetto scritto, cantato e prodotto da un artista YG, Psy. Rispetto all’immagine patinata delle contemporanee boy e girl band la sua figura risulta sicuramente comica, ma grazie a una base elettronica accattivante e a un balletto che viene voglia di imitare (ben prima di TikTok) in soli due mesi il video sfonda per primo la soglia del miliardo di visualizzazioni su YouTube. Nonostante i titoli di giornale e i 39 primi posti nelle classifiche mondiali, “Gangnam Style” non induce le agenzie a puntare su un’altra “novelty”, la curiosità buffa che lascia il tempo che trova; semmai capiscono di dover investire in modo ancora più massiccio sul canale che aveva decretato quel successo, i social network, e sul coinvolgimento diretto dei fan.
Dalla terza generazione K-pop in poi, gli artisti sanno che dovranno offrire un flusso continuo di scambio con la loro base. Si mostrano mentre si allenano e studiano, mentre falliscono e trionfano, puntando sull’empatia: il pubblico si sente allora partecipe degli alti e bassi dei suoi favoriti, responsabile dei suoi successi e insuccessi. Una combinazione di intimità e universalità micidiale sui social, che viene colta in modo particolarmente originale da una creatura di Big Hit/Hybe che debutta nel 2013: i BTS, o Bangtan Sonyeondan, cioè i “boyscout a prova di proiettile” – definizione perfetta degli idol in generale. Il loro messaggio di gentilezza e accettazione delle fragilità – universale per chi sia nato a Seoul come a Milano – è una forma di sostegno reciproco che il gruppo e la sua ARMY si danno a vicenda, una forma di resistenza ai pesi di una società performativa nella quale tutti – famosi o meno – siamo calati. I BTS ne fanno anche una missione umanitaria, quando nel 2017 Unicef li rende ambasciatori della campagna anti-violenza Love Myself (così perfettamente abbinata al progetto musicale Love Yourself). E tocca a loro sfondare nel mercato più grande al mondo: dopo un ultra-decennale lavoro ai fianchi della sottocultura, dalla creazione di un canale MTV per coreani-americani alle crescenti convention a tema, dai passaggi dei tour ai passaggi in tv, finalmente l’America nel 2018 cede alla wave. I BTS diventano la prima boy band K-pop a dominare le classifiche USA, con un singolo in top 10 e un album al primo posto. Oggi l’impatto del settetto sul PIL del loro paese si stima tra i 3 e i 5 miliardi di dollari: per questo l’invito alla Casa Bianca da parte di Biden l’anno scorso ha stupito solo i più distratti.
Di fronte allo sgretolarsi delle certezze e alle tensioni generazionali in Occidente, il futuro immaginato a Seoul non è una destinazione lontana, potenzialmente minacciosa, ma una visione affidata a chi quel futuro lo vivrà, possibilmente senza dimenticare certe tradizioni. Il K-pop, insomma, è una forma molto raffinata di ottimismo.
Nell’ascesa del K-pop viene inclusa spesso quella contemporanea del K-drama, tipo di polpettone melodrammatico la cui fortuna segue da lontano, ma in parallelo, il rinascimento filmico coreano. Da una parte abbiamo il premiatissimo Parasite (Palma d’Oro e Oscar) e la celeberrima serie Netflix Squid Game, con la loro critica allegorica al capitalismo più feroce dentro uno storytelling vibrante e spietato; dall’altra un’età dell’oro delle commedie romantiche a episodi, che tra un product placement e un amore da soap opera mettono di nuovo in luce una gioventù coreana che fa i conti con la sensibilità e il bisogno di affermazione personale. Anche il K-drama si fa largo nei servizi di streaming occidentali, operando in sinergia con l’industria musicale, che investe in produzioni o dà in prestito alle serie canzoni e volti: come Jisoo delle Blackpink, o Krystal delle f(x).
Ma, per quanto venga amplificata dal digitale, la hallyu non resta chiusa negli schermi: la sua portata è tangibile, e di nuovo i fan sono al centro. Il K-pop è probabilmente il genere musicale più venduto degli ultimi anni su supporti fisici: sono milioni e milioni i CD che il genere vende ogni anno, convincendo gli ascoltatori a investire ripetutamente in oggetti da collezione, ricchi di materiali e varianti dedicate ai singoli idol. E neppure Spotify può reggere il confronto: a febbraio, ad esempio, i Tomorrow X Together hanno scalzato SZA dal primo posto della chart americana quasi solo con le vendite fisiche del loro EP.
Non meno importante è il merchandising, dove il K-pop fa scuola unendo in modo virtuoso licensing e produzione, dai gadget ai fumetti, dalle agende all’abbigliamento. Un paragone esemplare: nel 2020 la più grande major discografica mondiale, Universal Music Group, incassava dal merchandising 217 milioni dei suoi 8,9 miliardi di dollari di entrate; nello stesso anno Hybe ne incassava 219 su poco più di 673 milioni totali. Con una fedeltà di questo peso, manifestata sistematicamente con il portafoglio, logicamente molti brand sono giunti alla stessa conclusione: gli idol sono la forma definitiva di influencer.
Ecco spiegato perché la tecnologia, lo sportswear ma soprattutto l’alta moda corteggiano il K-pop. Nel 2016, G-Dragon dei BIGBANG è stato il primo idol a essere scelto come brand ambassador, da un marchio come Chanel, aprendo la strada a una realtà in cui le stelle coreane sono ambitissime. Ormai la loro presenza alle sfilate occidentali è data per scontata. Il 15 gennaio, durante la settimana della moda maschile autunno-inverno a Milano, qualche migliaio di ragazzi ha circondato la Fondazione Prada, solo per inneggiare alla band Enhypen, invitata a una sfilata del marchio: è stata la prima boy band a presenziare al completo a un evento milanese, e forse non sarà l’ultima. Perché l’engagement dei loro fan non ha pari: come riporta Business of Fashion, la società di consulenza di moda Launchmetrics ha calcolato che il 41% dei post riguardanti celebrità e influencer durante la stagione della moda donna autunno-inverno 2021 a Milano era relativo proprio agli artisti K-pop; percentuale che sale al 50% nell’ultima settimana maschile, secondo la società Lefty. Del resto alle settimane di Milano e Parigi era presente il gotha del genere: tra gli altri Kai degli Exo da Gucci, di cui è ambassador dal 2019; e ben tre dei BTS, J-Hope da Louis Vuitton, brand legato all’intera band dal 2021, Suga da Valentino e Jimin da Dior, con i quali questi due hanno appena stretto accordi individuali; o ancora Jeonghan dei Seventeen e Ten degli NCT da Saint Laurent.
La scommessa è che il buzz sugli idol e il fanatismo dei loro seguaci si traducano in consumo, con l’ulteriore vantaggio di non rischiare di incorrere in possibili controversie grazie alla loro calibrata e pulita immagine pubblica. Con il K-pop, oggi, non si sbaglia. Perfino l’evento tv più visto al mondo, i mondiali di calcio, ha voluto Jungkook dei soliti BTS all’evento di apertura. Allo stesso modo, l’importante e cool festival Coachella ad aprile darà alle Blackpink il ruolo delle headliner, per creare ancora più hype intorno al suo palco principale. Sarà un ulteriore coronamento per il quartetto di casa YG che dal 2016 a oggi, con attitudine sexy e coreografie micidiali ha già ottenuto: 29 miliardi di views; accordi commerciali con Dior (Jisoo), Chanel (Jennie), Yves Saint Laurent (Rosé), Bulgari e Celine (Lisa); un documentario su Netflix. E adesso, letteralmente il palco più importante che ci sia.
Ma il K-pop non si lascia soltanto comprare da altri. Negli ultimi tre anni la Hybe ha messo a frutto i ricavi dei suoi BTS per fare la spesa: di recente ha ottenuto le quote di maggioranza della rivale SM in un intrigo degno di Succession che potrebbe cambiare gli equilibri interni di un sistema consolidato negli ultimi 18 anni. Non contenti, i boss dell’azienda hanno deciso di fare shopping anche negli USA: nel 2021 hanno pagato oltre un miliardo di dollari per le società che gestiscono la discografia e il management, tra gli altri, di Justin Bieber; lo scorso febbraio hanno comprato per 300 milioni Quality Control, influentissima etichetta trap dei Migos. Potrebbe trattarsi di semplici investimenti, o potrebbe trattarsi dell’inizio di una prossima fase. Sicuramente la wave non è ancora in risacca, perché non ha smesso di andare avanti, di guardare al futuro. Potrebbe essere un futuro di grandi acquisizioni, come quelle di Hybe; o un futuro di avatar, AI e deepfake, come intendono alcune società che hanno già investito concretamente in quelle tecnologie per creare nuove e realistiche occasioni di incontro tra fan e band, un metaverso che non sia un ridicolo giochino. Qualunque futuro sia, il K-pop lo sta già immaginando. Anche per noi.