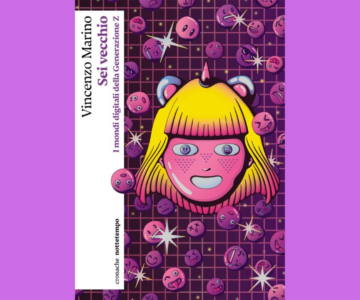Cosa succede alla promozione territoriale delle nuove “immagini-luogo” quando la narrazione istituzionale viene contaminata dalle rappresentazioni di tendenza di creator, influencer e utenti online?
da Quants numero 4, luglio 2023
«Lo spazio turistico è anzitutto un’immagine» scriveva negli anni Settanta il geografo Jean-Marie Miossec. Oggi forse ci sembrerebbe più sensato affermare che lo spazio turistico è un bel carosello nel feed, o un reel minuziosamente montato, in cui la voce dell’utente di turno accompagna una sequenza di immagini mozzafiato di luoghi “da visitare assolutamente”, consigliando mete inesplorate e tappe imperdibili attraverso cui fare esperienza di una destinazione. Fin qui niente di nuovo. Ma se è vero quello che sostiene Miossec, ovvero che l’immagine coincide con il luogo, la domanda sorge spontanea: come è cambiata la rappresentazione dello spazio turistico dai tempi delle guide e delle cartoline a quelli di Instagram e TikTok? E cosa succede alla promozione territoriale delle nuove “immagini-luogo” quando la narrazione istituzionale viene contaminata dalle rappresentazioni di tendenza di creator, influencer e utenti online?
Una risposta involontaria e parziale, ma non per questo meno importante per il suo impatto simbolico, viene suggerita proprio dall’Italia, e nello specifico dalla famigerata campagna che l’Agenzia Nazionale del Turismo ENIT ha lanciato per promuovere il territorio italiano nel 2023: “Open to Meraviglia”. L’operazione commerciale di ENIT persegue lo scopo di rilanciare le destinazioni del Belpaese e aumentarne la visibilità all’estero mettendo in campo una ambasciatrice inaspettata: la Venere di Botticelli, che nella campagna dell’ente si trasforma in una vera e propria influencer social, o meglio, in una “Virtual content creator and testimonial” come recita la bio del suo profilo fittizio su Instagram, @venereitalia23. In questo spazio, la Venere-influencer viene rappresentata mentre si scatta selfie sullo sfondo di destinazioni più o meno note al target dei viaggiatori internazionali: Roma, Capri, Ercolano, ma anche Valle di Diano e Vietri sul Mare. I post sono confezionati per imitare le tendenze di rappresentazione turistica più diffuse tra gli utenti online, cercando di rivoluzionare la comunicazione ingessata e istituzionale dell’Agenzia, camuffando i toni e abbattendo le dicotomie: il passato incontra la dimensione contemporanea, la tradizione erompe dai suoi canoni e dialoga con le pratiche del tempo libero moderno. La Venere mangia la pizza, va in bici e gioca a golf. Indossa jeans, bluse annodate sull’ombelico e caftani con nappe da vera turista borghese a Positano. Le critiche provenienti dal web hanno definito l’operazione approssimativa, mediocre, persino cringe. Eppure, nella sua inquietante stranezza la Venere-influencer è la perfetta dimostrazione di quel che è diventata l’immagine turistica oggi: una miscellanea di rappresentazioni culturali che producono una novità sempre uguale a sé stessa, in cui il tentativo di selezionare un messaggio originale volto a sottolineare l’autenticità di un luogo non fa altro che produrre l’effetto opposto, un senso di contraffazione di cui è difficile sbarazzarsi.
L’esempio della campagna ENIT è tra i più conclamati, se non altro per l’unanimità del dissenso ricevuto, ma il problema dell’immagine turistica digitale non si ferma agli scivoloni istituzionali, abbracciando l’intera pratica del discorso mainstream online. I video degli utenti riprendono il linguaggio del travel blogging e delle guide turistiche di massa, lo stesso che la Venere vorrebbe imitare, offrendo versioni gratuite e personali di rubriche di consigli in stile Lonely Planet: cosa vedere in 48 ore, come sopravvivere con poco budget, gli itinerari personalizzati, intelligenti e sostenibili, e infine i “POV” (acronimo per Point of view), ovvero i video che esaltano la sensazionalità dell’esperienza individuale a ritmo di hit, come veri e propri spot pubblicitari. Il format vale per qualsiasi destinazione: dai paesini in Umbria a Bali, fino ai consigli su come vivere le metropoli urbane fuggendo dai percorsi turistici per sperimentare la città come veri e propri “local”. Uno dei video che mi ha colpita di più è stato realizzato a Tokyo da un utente giapponese: nel reel, @jinfromjapan mostra la sua esperienza in un modesto negozietto di udon in un cui la proprietaria, una signora di 85 anni che da più di vent’anni gestisce da sola il locale, offre all’avventore autentiche specialità casalinghe preparate sotto i propri occhi, il tutto per una somma sorprendentemente modesta per gli standard della metropoli. A differenza dei soliti contenuti, il video si apre con un disclaimer inaspettato: «Non voglio che questo ristorante diventi sovraffollato, per favore non andateci», una richiesta che non può non suonare contraddittoria, soprattutto quando si osserva che l’account da cui è stato pubblicato offre regolarmente consigli turistici ai suoi 55 mila follower e che il video in questione è stato uno dei più apprezzati di sempre, arrivando a contare ben 24 milioni di visualizzazioni. Il cortocircuito è evidente: nella dimensione digitale come in quella turistica, la rappresentazione dell’autenticità è l’unica moneta di scambio possibile, anche a costo di dare in pasto sé stessa all’inevitabile fagocitazione dell’esperienza di massa. L’importante è continuare a produrre nuove versioni dell’autentico, non importa che siano guide di consigli prontamente sconfessati o foto di stock con la faccia della Venere appiccicata sopra.
La Venere mangia la pizza, va in bici e gioca a golf. Indossa jeans, bluse annodate sull’ombelico e caftani con nappe da vera turista borghese a Positano. Le critiche provenienti dal web hanno definito l’operazione approssimativa, mediocre, persino cringe. Eppure, nella sua inquietante stranezza la Venere-influencer è la perfetta dimostrazione di quel che è diventata l’immagine turistica oggi.
Ma la relazione tra i contenuti degli utenti e la campagna ENIT svela anche un altro aspetto della produzione degli immaginari turistici. Quando Miossec parla di luoghi e immagini, sottolinea la responsabilità degli attori culturali al centro della semplificazione territoriale, ovvero della riduzione di un luogo a una serie di simboli e rappresentazioni universali e accattivanti. Nel caso specifico, Miossec si rivolge alle agenzie di viaggio come ai principali operatori del discorso turistico, con il potere di selezionare e mediare l’iconografia territoriale per promuoverne una versione commercializzabile e fruibile.
Il potere di rappresentazione è quindi in mano ad agenti esterni, che alimentano le fantasie dello sguardo turistico operando una sofisticazione del discorso territoriale, attraverso quello che Miossec definisce un “doppio movimento” tra reale e immaginario, ovvero una compenetrazione reciproca tra elementi di ordinarietà e di meraviglia nella costruzione dell’immagine turistica, grazie alla quale una meta viene percepita al tempo stesso come desiderabile e familiare. Si tratta dell’integrazione del rapporto tra banalità ed esoticità e tra spettacolarità e quotidianità di cui parlano anche gli accademici Marco Aime e Davide Papotti nel loro saggio L’altro e l’altrove, in cui spiegano come la rappresentazione dell’alterità sia diventata il principale repertorio di marketing mediatico per promuovere qualsiasi aspetto dell’esperienza del mondo come una potenziale attività turistica. Non c’è più differenza tra la spiaggia incontaminata di Bali e il negozietto di udon a Tokyo: grazie al repertorio di immaginari pret-a-porter, entrambe diventano attrazioni accessibili e al tempo stesso da sperimentare con un senso di venerazione, rinnovando costantemente l’illusione di una frontiera di originalità accessibile a pochi.
Oggi, gli attori culturali al centro della semplificazione geografica si sono moltiplicati, aprendo la strada a una pluralità di rappresentazioni che, oltre a nutrire lo scambio tra ciò che è reale è ciò che è immaginario, producono un rapporto di imitazione reciproca tra vernacolare e formale, combinando lo stile confidenziale del passaparola a quello pubblicitario e promozionale: gli utenti imitano il linguaggio delle guide, le istituzioni inseguono i social trend, la Venere è una sedicente travel blogger. La contaminazione, tuttavia, non produce una differenza, né tantomeno l’apertura di un discorso “dal basso”, ma semplicemente una convivenza di narrazioni connesse e al tempo stesso separate tra loro, un ipertesto turistico il cui copione viene costantemente reimpastato senza produrre nuovi significati e, soprattutto, escludendo quasi sempre dalla sua scrittura gli stessi “local” che tanto si vorrebbe imitare e che finiscono irrimediabilmente per diventare ennesime attrazioni semplificate. In questa dimensione, si generano gli effetti culturali dell’iperturismo, ovvero della dimensione turistica globalizzata che incontra i canali di rappresentazione mediatica dei social network e che produce un irreversibile assottigliamento dei confini tra globale e locale, tra narrazioni autentiche e banali, tra esperienze “alternative” e di massa.
Nel 2020, il blocco dei flussi turistici internazionali ha causato un’ulteriore (e sicuramente controintuitiva) accelerazione dell’iperturismo: l’aumento esponenziale del turismo di prossimità, che secondo i dati del Touring Club Italiano ha coinvolto il 72% degli italiani, e l’adozione di pratiche turistiche “alternative” come il campeggio e il turismo all’aria aperta, invece di portare alla ribalta la dimensione locale e l’esperienza di un turismo più lento e contenuto, ha avuto come principale effetto quello di agevolare l’ingresso della retorica mainstream nelle dimensioni territoriali e nelle pratiche di turismo “di nicchia”.
L’ascesa del glamping, ovvero del fenomeno dei campeggi di lusso dotati di ogni comfort rispetto a un comune accampamento, spiega bene il ruolo del lockdown nella spinta all’iperturistificazione del viaggio di prossimità. Nel 2020, l’Osservatorio del Turismo Outdoor realizzato dal gruppo ricettivo Human Company, riportava che il 70,5% degli italiani aveva scelto di organizzare una vacanza all’aria aperta in reazione alle restrizioni pandemiche, contribuendo a una crescita del 26,6% del segmento outdoor rispetto al 2019. L’apertura della pratica di camping a nuove fasce di utenza – le stesse che prima del Covid avrebbero optato per soggiorni all’interno di strutture alberghiere o case vacanza – invece di ottenere l’effetto di avvicinare una nuova fascia di popolazione alle pratiche alternative ed economiche del campeggio “tradizionale”, ha finito per produrre una “resortizzazione” di queste ultime.
Una miscellanea di rappresentazioni culturali che producono una novità sempre uguale a sé stessa, in cui il tentativo di selezionare un messaggio originale volto a sottolineare l’autenticità di un luogo non fa altro che produrre l’effetto opposto, un senso di contraffazione di cui è difficile sbarazzarsi.
Secondo un’analisi prodotta nel 2022 da IlSole24ore, in Italia il numero di strutture only glamping e di strutture con soluzioni ibride (campeggio tradizionale + glamping) registra una crescita del 10% ogni anno. L’indagine conferma il ruolo giocato dal Covid nell’accrescere il successo di questa tendenza turistica, soffermandosi inoltre sugli aspetti di design che caratterizzano i glamping moderni: tende in tessuto multi-accessoriate, accampamenti sull’acqua o sospesi sugli alberi, ma anche chalet, bungalow di lusso e quelli che vengono definiti “carrozzoni gitani”, ovvero abitazioni outdoor che richiamano lo stile gipsy senza intrattenere alcun rapporto con la sua cultura. E la lista dei comfort iperturistici del glamping non finisce qui: durante l’edizione 2023 del Salone dell’Accoglienza Hospitality, la federazione delle imprese ricettive all’aria aperta Faita-Federcamping ha confermato una crescita del 20% del settore, parlando di bolle trasparenti con vista sul cielo stellato, di salotti nella natura e di campeggi dotati di Spa, mentre un’indagine sul glamping pubblicata da Risposte turismo menziona corsi di yoga e di meditazione, degustazioni, spazi per lo smart working e picnic. Tutti parlano di sostenibilità, di igiene e di sicurezza, ma soprattutto di turismo esperienziale, dove l’interazione con un territorio smette di essere il risultato spontaneo e incidentale della villeggiatura temporanea per diventare un vero e proprio servizio di cui usufruire contando sul mantenimento garantito di una serie di standard qualitativi. Tra questi, ovviamente, non manca l’effetto esotico dell’alterità, senza cui l’esperienza non verrebbe percepita come autentica. Perché mai altrimenti spendere centinaia di euro a notte per dormire in un carrozzone gitano?
È un fenomeno che osserviamo già da anni nella cosiddetta “borghizzazione” dei piccoli comuni italiani, che da centri principalmente animati da un turismo contenuto, spesso di origine locale e familiare, si stanno progressivamente trasformando in tante mini Disneyland confezionate per restituire al forestiero la perfetta rappresentazione incantata del folklore nostrano. Secondo uno studio condotto dall’azienda di consulenza Deloitte, si tratterebbe di una spinta incentivata non solo dalle restrizioni pandemiche, ma anche dalla progressiva ricerca da parte dell’utente di un turismo percepito come sostenibile e fuori dalle pratiche di massa: il 63% degli intervistati, infatti, sarebbe sempre più incline a cercare esperienze locali, “rivalutando i borghi del proprio paese” e perseguendo pratiche di turismo like a local.
Di “borghizzazione” delle aree interne e dei luoghi remoti parla anche la ricercatrice in geografia Francesca Sabatini che, in un capitolo del saggio Viaggiare nell’immaginario. Immaginare il viaggio edito nel 2023 da Giulia de Spuches e Leonardo Mercatanti, dedica una riflessione all’evoluzione degli immaginari e dei discorsi mainstream relativi ai territori decentralizzati. Come spiega Sabatini, il termine “borgo” è in realtà un’espressione di recente adozione che esprime un particolare sguardo sul territorio: un preciso modo di vedere i paesaggi marginali che finisce per applicare un filtro poetico e nostalgico sui luoghi e le pratiche di cui sono composti, contrapponendo irrimediabilmente gli aspetti caotici, complessi e moderni della città a quelli arretrati, genuini e placidi del villaggio. Il risultato dello sviluppo di questo particolare tipo di retorica negli anni è quello che il docente di storia moderna Rossano Pazzagli definisce “piccoloborghismo”, una visione che spoglia il territorio decentralizzato di qualsiasi complessità per ridurlo a un retreat domenicale di un turismo di classe. Come sottolinea Sabatini nel suo articolo: «In modo molto interessante, questa svolta del discorso sulle aree interne è coincisa con lo scoppio della pandemia, quando il discorso pubblico e mainstream su questi luoghi ha iniziato a popolarsi sempre di più dell’immagine del borgo come metafora di una generica alternativa all’urbano (…) Questo tipo di visione si è accompagnata allo stereotipo che questi luoghi possano ripopolarsi con nuovi abitanti intermittenti in smart working, introducendo cablaggi 4.0 e connessioni veloci con i poli urbani limitrofi. Una visione in cui il borgo diventa meta di nuovi insediamenti a condizione che ci sia tecnologia per superare le criticità e bellezza diffusa per alimentare turismo culturale e slow fuori dai circuiti di massa.»
Il borgo diventa la perfetta forma di “escapismo locale” per il turista urbano benestante: l’esperienza like a local spazia dalla workation, la vacanza-lavoro protetta dalla frenesia cittadina, alle scorribande di shopping ed esperienze enogastronomiche che caratterizzano il classico soggiorno estivo degli utenti dall’estero. Da questo punto di vista, il processo di staged authenticity, descritto da MacCannell per spiegare la riproduzione fittizia dell’autenticità nelle esperienze turistiche, passa per un’inevitabile staged artigianality di cui i borghi si fanno teatro, producendo un vero e proprio processo di franchising culturale dei territori: la pasta tricolore, le creazioni di cioccolateria dalle forme bizzarre, il pistacchio di Bronte, il vetro di Murano, le botteghe di pelletteria, il museo delle torture e i negozi di souvenir tutti uguali. L’esperienza dell’alterità è esoticizzata e al tempo stesso standardizzata reiterando incessantemente quel doppio movimento tra reale e immaginario di cui parla Miossec. A questo si aggiunge la diffusione di tradizioni inventate, messe in scena con la pretesa di ricreare nello spettatore il brivido dell’esperienza folkloristica per eccellenza: è così che festività create ex novo, sagre di prodotti generici e rituali imprestati gonfiano il nuovo universo culturale del fakelore, di cui il digitale è oggi la perfetta camera di risonanza, con la sua incessante riproduzione multimediale di attrazioni spacciate per autentiche, collettivamente inventate dallo sguardo forestiero che passa attraverso la fotocamera dello smartphone.
Il paradosso è ancora più evidente quando a emergere non è solo la fragile illusione di un turismo di massa in costante ricerca di un’elevazione di status sia dal “turista comune” che dal “local-esotico”, ma anche la fondamentale assenza di sostenibilità di una pratica di prossimità che vorrebbe porsi come alternativa eco & slow alle grandi mete. Su instagram, l’antropologo e blogger Pietro Lacasella (@altorilievo.vdm) racconta le trasformazioni dei paesaggi montani da un punto di vista paesaggistico, turistico e infrastrutturale. In alcuni post mostra la differenza tra gli scatti degli utenti e lo scenario concreto che ci si trova di fronte quando si visita un punto d’attrazione: le rappresentazioni mostrano sempre una natura incontaminata, che taglia fuori dall’obiettivo la massa turistica accalcata nello stesso luogo, un’orda inesauribile che, contemporaneamente, produce e diffonde la stesse identiche rappresentazioni contraffatte e romanticizzate. Da questo punto di vista, la produzione di immagini turistiche digitali finisce per generare un vero e proprio inquinamento culturale, talvolta causando danni alla stessa vita locale che si cerca di celebrare attraverso i propri ritratti online.
Nella dimensione digitale come in quella turistica, la rappresentazione dell’autenticità è l’unica moneta di scambio possibile, anche a costo di dare in pasto sé stessa all’inevitabile fagocitazione dell’esperienza di massa.
Due casi di attualità raccontano bene il problema dell’insostenibilità del turismo di massa nei piccoli centri: nell’aprile 2023, il comune di Portofino ha annunciato il divieto di sosta nelle aree più “instagrammate” del borgo marinaro, allo scopo di prevenire la congestione pedonale e il disturbo dei suoi abitanti e lavoratori, con sanzioni che vanno dai 65 ai 275 euro per chiunque trasgredisca il veto. Ma il caso più interessante è forse quello del piccolo villaggio di Hallstatt, in Austria, dove il traffico di turisti con lo smartphone sul belvedere che avrebbe ispirato i paesaggi del celebre film di animazione Frozen ha costretto il sindaco della cittadina a costruire una palizzata “anti-selfie” per proteggere la privacy e il sonno dei propri abitanti, costantemente importunati da flash e schiamazzi. Il caso di Hallstatt non è rilevante solo per la drasticità delle misure adottate dall’amministrazione cittadina, ma anche per i fattori che hanno contribuito a causare l’inquinamento iperturistico della località. Ad accrescere la fama del villaggio austriaco, infatti, avrebbe concorso anche l’iniziativa di un miliardario giapponese che nel 2012, ha deciso di far costruire una copia del paese vicino alla propria abitazione, a Guangdong, alimentando l’interesse turistico verso il villaggio da parte dei turisti giapponesi.
Il caso di Hallstatt è un caso di iperturismo per eccellenza: non si tratta solo dell’inesorabile massificazione delle mete e degli immaginari territoriali, ma anche e soprattutto dell’assorbimento di ogni dicotomia in uno spazio che traduce ogni elemento territoriale in un potenziale oggetto di scena per la spettacolarizzazione turistica. Se da un lato resta vero ciò che osserva Sabatini quando sottolinea che la rappresentazione commerciale di un territorio si fonda sempre di più sulla relazione asimmetrica tra il turista-colonizzatore e il local-colonizzato, dall’altro è altrettanto importante osservare come l’iperturismo finisca per annientare ogni forma di conflittualità trasformando qualsiasi pratica in un gioco di ruolo da festival fantasy (con tutto il dovuto rispetto per i festival fantasy).
Il suffisso “iper”, oggi accostato alla pratica turistica soprattutto per descrivere il sovraffollamento dei viaggiatori in una determinata meta, nasconde una radice filosofica che contiene importanti indizi sul ruolo culturale giocato dall’iperturismo nella costruzioni delle immagini territoriali. Nel suo saggio Iperculturalità. Cultura e globalizzazione, scritto nel 2005 e tradotto in Italia da nottetempo nel 2023, il filosofo sudcoreano Byung-Chul Han descrive l’ipercultura come una nuova condizione in cui il sapere globalizzato prende la forma di un mosaico, un universo a puntini che compone un «patrimonio di differenti stili e pratiche di vita che cambia, si amplia e si rinnova senza sosta, e in cui rientrano gli stili di vita dei tempi passati, de-storicizzati in chiave iperculturale». È un panorama sorprendentemente (o forse neanche troppo) simile a quello che stiamo vivendo oggi, diciotto anni dopo la prima pubblicazione del testo di Han: tra Frozen e la pasta tricolore, i campeggi con la Spa e i carrozzoni gitani, i finti gladiatori e le sedicenti influencer, l’immagine del mondo accelerata dal digitale è sempre più simile a una “moodboard ispirazionale” da salvare su Pinterest o condividere nelle proprie Instagram Stories. Il problema delle immagini “ispirazionali”, però, è che mentre propongono un’idea falsificata della realtà, la trasformano per assecondare sempre di più quella visione promettente e ingannevole.
Non è un caso che, nel suo saggio, Han paragoni l’iperculturalità alla nuova tendenza della cucina fusion, dove le differenze tra i diversi ingredienti e le tradizioni da cui provengono si dissolvono per generare una pietanza nuova, contemporaneamente familiare e inedita. I sushi-burrito, le pizze-tramezzino, i maritozzi-panino, gli avocado-burger: non sono solo esperimenti gastronomici per un turismo annoiato, ma veri e propri progetti di design del reale, in cui gli elementi vengono isolati dal loro contesto per produrre scenari innovativi. Il processo sembra inesorabile: a fine 2022, il report dell’agenzia multinazionale Wunderman Thompson, dedicato ai 100 trend per l’anno successivo, ha redatto una lista di nuove tendenze turistiche che spaziano dal turismo subacqueo (in cui vengono citata esplicitamente le spedizioni OceanGate) ai santuari urbani, i viaggi nel metaverso e le spedizioni in aree famose per le tragedie che vi sono state consumate, come Chernobyl e la foresta dei suicidi in Giappone, Aokigahara. Negli stessi mesi Airbnb ha annunciato i vincitori del suo fondo WOW!, un premio per la realizzazione di strutture eclettiche e iperreali da inserire nella sua lista di opzioni di villeggiatura. Tra i vincitori c’è una casa-avocado (frutto simbolo per eccellenza dell’iperculturalità), una villa a forma di scatola di cereali e un alloggio-alveare.
È questa la nuova immagine dei luoghi iperturistici e digitalizzati? Quando Miossec scriveva negli anni Settanta, la rappresentazione turistica emergente che preoccupava i suoi studi era quella dei club mediterranei e dei villaggi vacanza, che secondo il geografo rappresentavano, per l’individuo moderno alienato, la perfetta utopia recintata dove delocalizzare le proprie preoccupazioni e regredire alla passività dei piaceri infantili. Oggi, gli immaginari territoriali che viaggiano attraverso la dimensione digitale contribuiscono ad alimentare l’utopia, a simulare «un mondo che non è un mondo» (per citare le parole di Han), influenzando irrimediabilmente il reale nel costante tentativo di accogliere in sé l’immaginario.
Proprio mentre scrivo, su Instagram la Venere di Botticelli ci fa sapere di essere appena sbarcata a Taormina. Indossa un vestito boho-chic e racconta il suo viaggio condividendo scatti di teste di moro in ceramica, vicoli fioriti e scorci da cui intravedere l’Etna. Verso la fine del carosello fotografico, un giocoso collage combina immagini di granite e brioche sullo sfondo di un mare cristallino, mentre una scritta chiede al lettore: «granita o cannoli?». A quanto pare, nell’universo semplificato e massificato dell’iperturismo, questa resta ancora l’unica scissione in grado di generare conflitto.