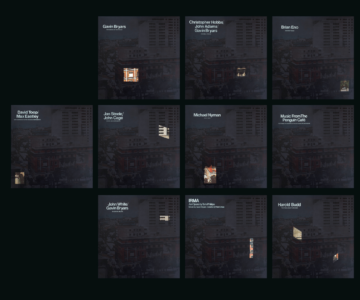Perché Ryūichi Sakamoto è stato il più celebrato musicista del Sol Levante. E perché è giusto che sia così.
da Quants numero 3, giugno 2023
Il primo album di Ryūichi Sakamoto, Thousand Knives (1978), si chiude con un brano strumentale intitolato “The End of Asia”, un’intricata giungla di spezie sintetiche che intarsia melodie minimali su ammiccanti ritmiche robotiche e che ai cinque minuti e mezzo improvvisamente si dissolve, per lasciare spazio a un’inquietante fanfara di tastiera, deforme e grottesca, dal gusto vagamente mortuario. Quel breve frammento, posto significativamente in chiusura del disco, evoca la melodia di “The East is Red”, inno della Repubblica Popolare Cinese al tempo della rivoluzione culturale maoista. Un modo sottile attraverso il quale il già acclarato genio nipponico da una parte confermava il suo interesse per la tradizione musicale cinese e nel contempo certificava la sua presa di distanza da ogni tentativo di cavalcare stereotipi “orientalisti”. E ribadì il concetto, in modo ancor più provocatorio, qualche mese più tardi, all’uscita di Solid State Survivor, il secondo album della Yellow Magic Orchestra. La copertina del disco ritrae i tre pionieri del techno-pop — tra i quali il nostro eroe — accompagnati da due automi e vestiti con le tute rosse maoiste, mentre giocano a Mah Jong sorseggiando una Coca Cola, simbolo dell’imperialismo americano che cozza fragorosamente (e intenzionalmente) contro ogni facile semplificazione monolitica della cultura cinese e più in generale del mondo asiatico.
L’esistenza della “musica giapponese moderna” non è, naturalmente, una cosa che dipenda in toto da Sakamoto; è però soprattutto a lui e all’inequivocabile bellezza e profondità della sua opera che dobbiamo il superamento, su larga scala, di quell’accozzaglia di luoghi comuni che per decenni ha dominato l’immaginario degli occidentali nei confronti di esotici oggetti culturali come appunto “la musica asiatica”, non più percepita come indistinta paccottiglia folklorica “da un mondo lontano”.
E dire che il Giappone forse “non meritava” un ambasciatore musicale come Ryūichi Sakamoto, che si è spento lo scorso 28 marzo dopo anni di lotta contro una terribile malattia, affrontata sempre alla luce del sole, con un processo di condivisione pubblica non già del dolore ma della sua elaborazione (che è tutt’altra cosa). In due parole, è grazie a lui se la musica giunta a noi dall’estremo oriente, dalla fine degli anni Settanta in poi, ha smesso di venire sottovalutata per partito preso. Ed è anche grazie a lui se l’incontro, all’epoca ardito, fra la ricerca musicale in campo tecnologico (leggi: elettronica) e quella etnografica a ritroso verso le radici popolari, ha dischiuso uno sconfinato universo di possibilità creative del quale le contaminazioni del presente sono tutte in qualche modo figlie.
Ci permettiamo di azzardare che il Giappone “non meritasse” Sakamoto perché chi ha governato la terra del Sol Levante nell’ultimo secolo e mezzo non ha precisamente puntato sulla musica per esportare la propria cultura, da quando divenne inevitabile sottrarsi al plurisecolare isolamento dal mondo. Sappiamo bene che il sushi, i manga, gli anime, i videogiochi, le arti marziali e gli scorci naturali dalla bellezza sospesa sono da sempre i biglietti da visita, turistici e non solo, del Paese, mentre alla musica è toccato un destino strano. Pur vantando un “suono tradizionale” tra i più inconfondibili al mondo (qualcuno direbbe “tra i più ostici e inascoltabili”…), i giapponesi hanno scelto di adottare fin dal primo Novecento la notazione musicale occidentale nei programmi scolastici, subendo nel primo dopoguerra il fascino “licenzioso” del jazz e poi un’autentica colonizzazione culturale radiofonica con il Far East Network, subito dopo la bomba. Il risultato è stato che un paio di generazioni di musicisti nipponici sono cresciute intrappolate “tra uno pseudo-Occidente e un finto Giappone”.
Sono parole di Takashi Matsumoto, batterista e paroliere degli Happy End, la band che al principio degli anni Settanta scosse la scena musicale del Sol Levante fino a ingenerare un dibattito sulla possibilità, o meno, di cantare la musica rock in lingua giapponese. Una cosa che, evidentemente, toccava nervature identitarie assai sensibili e che prima degli Happy End alcuni avevano già fatto, utilizzando però stili canori tradizionali nipponici. Suonare ‘esattamente’ come Crosby, Stills, Nash & Young riuscì alla perfezione solo agli Happy End, che scrivevano canzoni del tutto simili a quelle della controcultura americana e le cantavano in una lingua “nazionale” storpiata nelle cadenze e vagamente aliena per il pubblico. Eppure, quel nuovo stile influenzò pesantemente la musica giovanile giapponese, che stava evolvendo dall’imitazione scadente dei modelli angloamericani degli anni Sessanta verso quella invece sofisticata, brillante e talvolta superiore agli originali messa a punto nel corso dei Settanta da un gruppo di giovani che si dimostrarono straordinariamente talentuosi, in particolare sul versante della fusion (vedi anche solo la colonna sonora dell’anime Lupin III) e di quel misto fra AOR, disco-music, Brian Wilson e ancora fusion che gli occidentali impareranno a conoscere solo dopo il 2010 con il nome di “city-pop”. Ad ascoltare oggi tanti dischi giapponesi di mezzo secolo fa stupiscono le capacità “produttive” — davvero maiuscole — che permisero in particolare ad Haruomi Hosono (ex bassista degli Happy End) di attorniarsi di un cenacolo di musicisti eccezionali, capaci di maneggiare qualunque linguaggio sonoro senza alcuna remora filologica (quella che, altrove, avrebbe impedito a un musicista di rhythm and blues di suonare il country, o a un musicista progressive di inserirsi nella scena punk). Per dei giovani giapponesi cresciuti nella confusione identitaria del Dopoguerra il problema neanche si poneva.
E il più eccezionale fra i musicisti che emersero in quel periodo è stato Ryūichi Sakamoto. Uno dei più giovani ma di sicuro il più colto, nonché il più spregiudicato nel gettarsi verso l’ignoto e le contaminazioni più inaudite. A differenza dei colleghi, che per lo più erano reduci della scalcinata stagione “beat” del Sol Levante, Sakamoto aveva seguito corsi universitari di composizione, interessandosi soprattutto all’elettronica e all’etno-musicologia. Ma non era una carriera accademica quello a cui puntava, tanto che nel 1975 cominciò a frequentare gli studi di incisione come session-man, muovendosi disinvoltamente tra la fusion, i cantautori, il pop e persino il free-jazz. E facendo ovunque grande impressione, tanto che dal 1977 cura gli arrangiamenti degli album di Taeko Ohnuki (ritenuti dei capolavori del city-pop) e prende parte con regolarità ai progetti che ruotano intorno ad Haruomi Hosono.
La musica di Sakamoto non perde mai la connessione con il pop, che anzi è sempre uno dei suoi orizzonti.
Per farsi un’idea di quanto fosse febbrile l’attività e inesauribile la creatività di quel 26enne che sbalordiva tutti, basti dire che nel solo 1978 Ryūichi Sakamoto viene coinvolto nella lavorazione di una trentina di album, tra i quali almeno una manciata di capolavori. Ma quell’anno è soprattutto cruciale perché nasce la Yellow Magic Orchestra. Hosono ne sarebbe teoricamente il leader ma riconosce il valore dei colleghi (il terzo è il batterista Yukihiro Takahashi, anch’egli compositore e scomparso tra l’altro quest’anno, due mesi e mezzo prima di Sakamoto…), così la formazione nasce paritaria da subito. Con un quarto elemento, l’ingegnere del suono Hideki Matsutake, fondamentale perché l’obiettivo è mettere le mani sul futuribile sound elettronico dei teutonici Kraftwerk, il gruppo che aveva trovato un’inedita quadra tra un sound spericolatamente innovativo e al tempo stesso capace di intrigare anche il pubblico del pop, grazie a un’efficace sintesi di filosofia distopica, iconografia robotica, presenza scenica teatrale e la non scontata appiccicosità di canzoni che suonavano aliene ma si potevano ballare e persino canticchiare. La Yellow Magic Orchestra parte da qui ma riesce a suonare ancora più pop, tra elastiche movenze fusion, ironici richiami all’altrettanto nuova musica dei videogame, affondi melodici luminosi e soprattutto una maniera obliqua e post-moderna di giocare con le sonorità etniche e gli stereotipi di cui l’Occidente aveva abusato per raccontare (e parodizzare) l’Asia. La musica “exotica”, che risuonava dai fiammanti impianti hi-fi dei playboy americani degli anni Cinquanta e Sessanta, e che di solito era un concentrato di luoghi comuni “terzomondisti” più o meno edulcorati in salsa swing, è precisamente l’“offesa culturale” alla quale Sakamoto si incarica di rispondere, arrangiando una cover in chiave techno-pop di un brano di Martin Denny, uomo-simbolo della musica exotica. E vale la pena sottolineare che il “techno-pop” era un linguaggio praticamente ancora tutto da inventare, che permette per la prima volta a una band di sconosciuti musicisti giapponesi di girare il mondo, colonizzando immaginari televisivi (la “Rydeen” scritta da Takahashi è stata la sigla di Bis di Mike Bongiorno) e arrivando persino a suonare nella Mecca — sempre televisiva — della musica afroamericana: il programma Soul Train, che nel 1980 li consacrò.
Il gruppo non avrà vita troppo lunga, ma i tre titolari non hanno mai smesso di collaborare e riunirsi spesso e volentieri; parliamo di un’autentica bandiera della musica giapponese, il cui sound sinuoso e proiettato verso il futuro ha marchiato a fuoco l’immaginario collettivo di un Paese che negli anni Ottanta toccò probabilmente il massimo del suo splendore economico. E la Yellow Magic Orchestra, in campo musicale, contribuì come nessun altro a sradicare dalla mente dei giapponesi complessi di inferiorità di scala nazionale.
Un paio di generazioni di musicisti nipponici sono cresciute intrappolate “tra uno pseudo-Occidente e un finto Giappone”.
Ma uno come Sakamoto non poteva certo vincolare il suo genio a una band, per quanto affermata e avventurosa. Dalla fine degli anni Settanta, oltre a stabilire un sodalizio artistico e sentimentale con una cantautrice originalissima come Akiko Yano, avvia una carriera solista tanto indefinibile quanto preziosa, muovendosi costantemente fra il molto antico e il molto moderno; e quindi sempre su accidentati ma fertilissimi terreni di confine, tra la musica colta (l’impressionismo di Debussy è una grande influenza), la ricerca etnica meno impolverata e le possibilità espressive dell’elettronica e del minimalismo (che approccia in maniera particolarmente visionaria nel 1985, sull’incompromissorio album Esperanto, da confrontare oggi coi più decantati progetti di musica elettronica del XXI secolo). Insieme ai Kraftwerk, anche Brian Eno è di certo un ispiratore, ma a differenza di chi lavora soprattutto con le nuove tecnologie, Sakamoto ha una formazione a 360 gradi e può vantare esiti compositivi di un’eleganza tale da far rizzare le orecchie anche anche agli ascoltatori del jazz e della classica. Il talento multiforme e la creatività onnivora che mostra in un disco-summa come Ongaku Zukan / Illustrated Musical Encyclopedia (1984) possono scomodare paragoni anche con un Duke Ellington, da immaginare immerso in un mondo più schizofrenico e traboccante di stimoli e connessioni mediatiche.
Ed è un aspetto, questo del mondo che si rimpicciolisce grazie ai nuovi mezzi di comunicazione, che Sakamoto colse con grande pionierismo. Anche per questo la sua musica non perde mai la connessione con il pop, che anzi è sempre uno dei suoi orizzonti. Lo dimostra un album giovanile come Summer Nerves (1979), di solare baldanza easy-listening, mentre anche in un disco spigoloso come B-2 Unit (1980) trovano spazio intuizioni che anticipano le grammatiche ritmiche dell’hip-hop, dell’IDM e del break-beat. Quello della canzone pop è però forse il solo terreno nel quale Sakamoto si sia cimentato senza riuscire a eccellere. Il problema principale è che non è un vero cantante, tanto che il pur valido Left Handed Dream (1981) non lo trasforma nel “Bowie giapponese”, ma l’incontro fra i due giganti dovrà attendere giusto un paio d’anni, e arriverà sul set del film Merry Christmas Mr.Lawrence, con Bowie attore protagonista e Sakamoto anch’egli attore ma soprattutto autore delle musiche. Che sono straordinarie, le più classiche, melodiche e suadenti mai composte fino a qui, tanto che la titletrack di quella colonna sonora diventerà di fatto la sua signature song (strumentale o cantata da David Sylvian come “Forbidden Colours”). Nomi come quelli di Bowie e Sylvian dicono quanto lo status di Sakamoto stesse crescendo pure in Occidente e certificano l’acume del giapponese, che sceglie di lavorare pressoché sempre con colleghi di enorme talento e di larghissime vedute, refrattari a porre confini al proprio estro. Gente come Adrian Belew, Arto Lindsay, Youssou N’Dour, il più volte ritrovato Sylvian, i coniugi Morelenbaum e anche Caetano Veloso. La mole della sua discografia è ingente — attraversa ambiziosi progetti fra synth-pop e world-music come Neo Geo (1987) e ripiega spesso e volentieri sulla nudità pianistica di dischi splendidi come Coda (1983) e /05 (2005) —, ma sorprende soprattutto la qualità media molto alta, dovuta chiaramente al talento ma anche a una curiosità che l’uomo non ha mai smesso di nutrire (anche come produttore e divulgatore, dall’etichetta Commmons ai numerosi festival organizzati, fino al progetto educativo “Schola”) e al rispetto che si deve anzitutto a sé stessi, e si mette in pratica con accurate selezioni del materiale da pubblicare.
Nel solo 1978 Ryūichi Sakamoto viene coinvolto nella lavorazione di una trentina di album, tra i quali almeno una manciata di capolavori.
Il fatto di comporre per lo più musica strumentale e non essere quindi inquadrabile come artista pop al 100% (Beauty del 1989 è forse il tentativo più riuscito, di enorme raffinatezza), potrebbe per paradosso avere aiutato Sakamoto a farsi un nome in un Occidente da sempre poco propenso a concedere possibilità di successo alle canzoni cantate in lingue “esotiche”. Non a caso, è stato il cinema a dare a Sakamoto la piena affermazione internazionale, specie dopo l’Oscar per le musiche de L’ultimo Imperatore di Bertolucci (condiviso peraltro con David Byrne). Del resto, se lo chiedete a un giapponese Sakamoto è certamente un mito, un punto di riferimento culturale (lo sarà anche su temi come l’ambiente e il nucleare), ma in patria non è probabilmente “il” musicista più famoso. Sarebbe come pretendere che tutti gli italiani ritenessero Morricone più importante di Celentano. Pur senza mai abbandonare il sogno del pop, Ryūichi Sakamoto intensifica la produzione di orientamento classicamente “colto” soprattutto dalla seconda metà dei Novanra, e dopo il 2000 si misura da protagonista con le nuove frontiere dell’elettronica digitale e in particolare dell’estetica glitch, alla quale contribuisce distillando gusto e sapienza armonica sia in solo che attraverso collaborazioni con esponenti chiave del settore come Carsten Nicolai e Christian Fennesz.
L’album Async, uscito nel 2017 quando già si sapeva della sua malattia, è un capolavoro di composizione minimalista al confine con l’ambient, un altro terreno esplorato sempre più nel corso degli anni; una musica che si rarefa fin quasi al limite del silenzio su 12, il disco di commiato uscito poche settimane prima della morte, fatto solo di flebili bordoni elettronici, un rado rintoccare pianistico e il respiro, affannato, del compositore, che scandisce tempi troppo umani per cercare un’inutile perfezione. Ha sempre avuto troppo da dire e troppo da fare, Ryūichi Sakamoto, per fermarsi a contemplare come Narciso la sua opera. Tanta e tale da riempire di bellezza le vite di tutti.