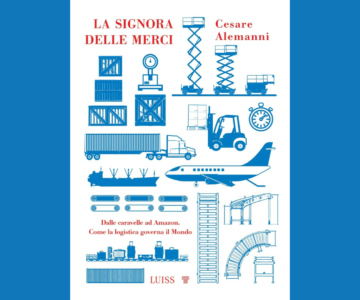Da ottant’anni la moneta statunitense è il fulcro del sistema finanziario globale, per molti, precisi motivi. Ma sarà così ancora a lungo? I BRICS, soprattutto la Cina, per esempio lottano per un cambiamento: quali sono allora gli scenari cui potremmo andare incontro?
da Quants numero 5, settembre 2023
«Il denaro e la moneta sono cose ben strane» scriveva l’abate di Tournai nel 1349, nel pieno di un’inflazione locale causata dalla grande pestilenza di quegli anni. E dire che, nel Trecento, le stravaganze delle monete erano poca cosa, per quantità e rilievo, se paragonate a quelle odierne. Oggi la moneta, che nel frattempo si è in gran parte smaterializzata diventando puro indice contabile, è il perno di un numero enorme di relazioni globali. Le più importanti delle quali, e non potrebbe essere altrimenti, ruotano da ottant’anni intorno al dollaro. Questo poiché — contrariamente al parere di John Maynard Keynes, che perorava la creazione di un’apposita moneta mondiale — nel 1944, a Bretton Woods, si decise che sarebbe stato il dollaro, in un rapporto di convertibilità fissa con l’oro, il fulcro del nuovo sistema finanziario globale che sarebbe, da lì a poco, sorto sulle ceneri della Seconda Guerra Mondiale, dopo il tramonto dei grandi imperi europei e della loro influenza sulle finanze planetarie.
Ma cosa significa dire che una moneta è il fulcro del sistema finanziario internazionale? Per capirlo, bisogna ricordarsi che l’economia non è una scienza esatta, né una disciplina nettamente separata dalla sfera sociale, come, per esempio, la fisica e altre “scienze dure”. L’economia è anzi la riproduzione sintetica, più o meno fedele, di miliardi dì interazioni tra esseri umani. Per questo motivo, una delle virtù più apprezzate dagli agenti economici è la fiducia. Specie quando si tratta degli strumenti a cui essi affidano la misurazione della ricchezza e la relazione tra le cose e la possibilità di acquistarle, la fiducia è fondamentale. Per questo motivo, da quando le monete sono emesse in esclusiva da entità politiche definibili come Stati o, talvolta, federazioni (non sempre è stato così e, con ogni probabilità, non lo sarà per sempre), il loro valore è espressione diretta della fiducia che tali entità sono in grado di ispirare. Il valore della moneta sprigiona infatti non da qualche magica qualità dell’inchiostro con cui è stampata, ma dalla credibilità del banchiere centrale che l’ha firmata.
Il valore della moneta sprigiona non da qualche magica qualità dell’inchiostro con cui è stampata, ma dalla credibilità del banchiere centrale che l’ha firmata.
Per questo le monete degli Stati più affidabili sono anche le più richieste. Nessuno vuole trovarsi il portafoglio pieno di denaro inservibile, perché lo Stato che ne garantiva il valore è fallito o è stato smantellato dopo aver perso una guerra. E dunque, più è difficile immaginare il tracollo economico, politico o militare di uno Stato, e più affidabile e richiesta risulterà la moneta che esso emette. Per questa ragione, a meno di inventare, come proposto da Keynes, uno strumento contabile ad hoc, era inevitabile che, nel dopoguerra, fosse il dollaro a occupare una posizione di prominenza nel sistema economico internazionale. Quale paese più degli Stati Uniti, nel suo splendido isolamento e col suo strapotere militare, tecnologico e finanziario, poteva ispirare la fiducia richiesta dal ruolo? Negli anni Cinquanta il predominio del dollaro era un fatto naturale. Con l’Europa in macerie, l’America divenne — anche grazie agli effetti del Piano Marshall — il più grande paese produttore-esportatore di merci al mondo. Chi voleva acquistare tali merci, doveva giocoforza prima procurarsi dei dollari per pagarle. È anche così che il dollaro divenne… il dollaro, e, di seguito, col tempo, l’Eurodollaro, l’Asiadollaro e soprattutto il famigerato Petrodollaro, a seguito della crisi petrolifera degli anni Settanta. Essendo la moneta più fidata del mondo, non solo gli USA, ma chiunque avesse qualcosa da mettere sulla bilancia del commercio internazionale, cominciò a chiedere “biglietti verdi” (greenbacks) in cambio.
Come insegna l’Uomo Ragno, “da grandi poteri derivano grandi responsabilità”. La posizione unica del dollaro, da quasi ottant’anni a questa parte, fa sì che le decisioni finanziarie degli Stati Uniti abbiano un peso mondiale superiore a quello di qualunque Stato (l’avrebbero comunque, data la dimensione dell’economia USA, ma non di pari portata). Questo è particolarmente vero nel caso di decisioni che riguardano le monete. Quando la FED determina la propria politica sui tassi d’interesse, la scelta non riguarda solo gli Stati Uniti ma il mondo intero. Lo stiamo vedendo in questi anni. Lo si vide chiaramente negli anni Settanta, quando la questione dei tassi fu una delle ragioni che spinsero Nixon a decretare la fine degli accordi di Bretton Woods citati in partenza.
La loro bilancia commerciale è ampiamente in attivo, la Cina è il maggiore esportatore di materie prime e il principale compratore di energia, eppure, si lamentano a Pechino, deve ancora vivere in un mondo in cui le viene chiesto di utilizzare dollari per compiere molte di queste operazioni.
Ma il tramonto di Bretton Woods non significò la fine della centralità del dollaro, anzi. Come tutte le altre monete, il dollaro venne lasciato libero di fluttuare senza alcun corrispettivo aureo, e la decisione sul suo valore venne affidata al mercato (o agli interventi svalutativi delle Banche Centrali, come ci ricorda la vicenda della nostra lira). Ciò conferì, paradossalmente, un maggiore potere alla moneta americana. Essendo la più richiesta, essa uscì rafforzata dal “libero gioco” dei mercati valutari. Così facendo gli Stati Uniti si trovarono in mano un potente strumento per condizionare l’intero apparato finanziario globale. Grazie a tale potere, gli Stati Uniti si sono dimostrati capaci di scatenare, più o meno volontariamente, “crisi del debito” in paesi in via di sviluppo, semplicemente rialzando i tassi sul dollaro.
Come detto, tuttavia, per quanto apparentemente insondabili e complesse le loro fluttuazioni, il pilastro su cui si reggono le monete è essenzialmente la fiducia. Ed è innegabile che il livello di fiducia che, a tutti i livelli, gli Stati Uniti sono stati in grado di ispirare negli ultimi vent’anni è molto diverso da quello che li caratterizzava nel dopoguerra. Le avventure militari fallimentari in Afghanistan e Iraq (e ancora prima in Vietnam), la crisi finanziaria del 2007/2008, l’eccessivo ricorso al sanzionismo, la perdita di affidabilità arrecata da Trump, sono tutti fattori che hanno contribuito a mettere in dubbio la leadership americana e, di riflesso, il prestigio del dollaro. C’è da dire inoltre che oggi le condizioni dell’economia internazionale sono molto diverse da quelle di ottant’anni fa. Se al tempo la bilancia commerciale USA era abbondantemente in attivo (ovvero: gli Stati Uniti esportavano/vendevano più di quanto comprassero/importassero), oggi è vero l’opposto. Il che elimina la ragione primaria, quella più pragmatica, per cui il dollaro era venuto a trovarsi nella posizione in cui oggi si trova. C’è poi il fatto che, nei postumi del 2008, è diventato sempre più evidente come, dal punto di vista finanziario, quello del dollaro rappresenti, per gli Stati Uniti, davvero un “esorbitante privilegio”, come da celebre definizione di Giscard D’Estaing. A differenza di ogni altro paese al mondo, l’America può decidere di iniettare enormi quantità di denaro (lo ha fatto Obama in occasione del piano Summers, è accaduto durante e dopo il Covid) per tamponare i propri problemi economici più macroscopici, scaricando parte degli effetti svalutativi di questa scelta sul resto del mondo. In altre parole, il privilegio del dollaro consente agli Stati Uniti di aumentare il proprio debito facendoselo indirettamente finanziare dal resto del mondo. Questo almeno per quanto riguarda la contabilità effettiva, perché in realtà i costi simbolici, e politici, delle scelte di deficit americane si stanno rivelando sempre più alti. Negli ultimi quindici anni, gli Stati Uniti sono stati il centro di irradiazione di una delle più gravi crisi finanziarie della Storia, e hanno dovuto innalzare il cosiddetto “tetto del debito” più volte di quanto avessero fatto nei cento anni precedenti. Insomma, se come dicevamo all’inizio, le monete non sono altro che “debiti basati sulla fiducia” (MacLeod), negli ultimi decenni paiono aver perso smalto almeno due dei pilastri su cui si reggeva la fiducia nella moneta USA: l’affidabilità finanziaria e la pulizia contabile.
Oggi, il dollaro è ormai una merce/servizio — un brand a tutti gli effetti — che gli Stati Uniti producono per il resto del mondo. Anche al netto di tutte le criticità, non è detto che qualcuno riuscirà, a conti fatti, a mettere sul mercato un prodotto migliore.
La situazione è resa ancor più fragile dal fatto che questa relativa eclissi di prestigio del dollaro ha coinciso con l’ascesa di nuovi poteri economici e attori geopolitici, su tutti la Cina. Che è, al contempo, il paese con la più ampia riserva di valuta straniera al mondo e quello più insoddisfatto dell’attuale stato degli affari monetari globali. Non è un caso dunque che Xi Jinping sia, da tempo, il più diretto nel criticare la posizione del dollaro. E in effetti ai cinesi non mancano gli argomenti: la loro bilancia commerciale è ampiamente in attivo, la Cina è il maggiore esportatore di materie prime e il principale compratore di energia, eppure, si lamentano a Pechino, deve ancora vivere in un mondo in cui le viene chiesto di utilizzare dollari per compiere molte di queste operazioni. A Xi si accodano anche gli altri leader dei cosiddetti BRICS (il raggruppamento delle economie mondiali di Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica). Non passa giorno ormai senza che questi denuncino come il Re Dollaro sia nudo e come, di fatto, la sua posizione sia ormai retta più dalla mera potenza (anche militare) dell’America che dall’effettiva salute e trasparenza degli apparati finanziari e politici USA. I BRICS, e in particolare la Cina, non si limitano a vocalizzare lamentele ma negli ultimi anni si sono mossi per cambiare la situazione. Un progetto come la famigerata Via della Seta, con gli imponenti flussi finanziari che lo contraddistinguono, è anche un modo, in fondo, per mettere in circolo renminbi. Per non dire del fatto che è notizia di questi mesi il tentativo cinese di convincere l’OPEC ad accettare anche yuan come pagamento del petrolio, costruendo così il petroyuan come “valuta energetica” alternativa, potenzialmente accessibile a tutti i paesi non allineati.
Siamo quindi prossimi a un tramonto definitivo del dollaro, un tramonto che segnerebbe, senza dubbio, anche l’inizio della fine dell’egemonia Americana? Non è detta l’ultima parola. Come visto, la posizione del dollaro è oggi più che mai difesa dalla superiorità della potenza militare americana. Una superiorità che non possiamo sapere se e quando verrà mai messa davvero in discussione, ma non pare faccenda di pochissimi anni. Inoltre, così come le monete sono basate sulla fiducia, esse finiscono anche per rivestirsi dei valori in cui si riconoscono coloro che ne fanno uso. Ed è innegabile che il dollaro sia ormai diventato sinonimo dell’ordine liberale occidentale. È dunque evidente che, anche solo per ragioni culturali e ideologiche, difficilmente esso verrà abbandonato a cuor leggero (a meno di una forte candidatura dell’Euro per rimpiazzarlo) da chi fa parte di quell’ordine o da chi, fuori dall’Occidente, intende segnalare la propria volontà di aderirvi. Esiste dunque la possibilità che, più che a un processo di de-dollarizzazione, assisteremo a una frammentazione, per linee più politiche che finanziarie, delle aree di circolazione valutaria: un mondo occidentale-liberale, più relativi alleati sparsi, imperniato ancora sul dollaro, e il mondo BRICS in orbita allo yuan o a qualche altra valuta (rispolverando la vecchia idea di Keynes, i BRICS stanno valutando di creare una moneta ad hoc). Gli effetti che tale frammentazione avrebbe sull’economia globale sono tutti da immaginare, e non è detto che siano necessariamente negativi.C’è infine da considerare che per, quanto non in forma smagliante, il dollaro è ancora oggi usato nell’80% delle transazioni internazionali. Una percentuale strabiliante che difficilmente si potrà azzerare di colpo. Di fatto, oggi, il dollaro è ormai una merce/servizio — un brand a tutti gli effetti — che gli Stati Uniti producono per il resto del mondo. Anche al netto di tutte le criticità che abbiamo esposto, non è detto che qualcuno riuscirà, a conti fatti, a mettere sul mercato un prodotto migliore.