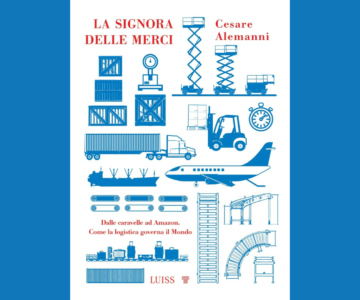Fino a pochi anni fa sembrava, sbagliando, che il miglior complimento che si potesse fare a un videogioco fosse quello di “sembrare un film”. Ora forse cominciamo ad accorgerci che lo specifico videoludico è in grado di veicolare emozioni e valori aggiunti pressoché impossibili da replicare.
da Quants numero 2, maggio 2023
Sono passati “solo” dieci anni dall’uscita del primo capitolo di The Last of Us, videogame da cui è tratta una recente serie tv su cui torneremo, ma sembra un’era geologica. Per dirne soltanto una, nel 2013 la maggioranza dell’opinione pubblica ancora considerava i videogiochi un passatempo infantile.
Se in gran parte del mondo avanzato oggi non è più così (tranne forse in Italia) parte del merito è in fondo proprio di The Last of Us. Il titolo di Naughty Dog ha avuto il merito di guadagnarsi il rispetto di parti della critica e del pubblico che non avevano mai considerato i videogame come un mezzo di intrattenimento per adulti. The Last of Us è riuscito a spezzare questo pregiudizio grazie a una narrazione ricca di sentimenti complessi e di morali ambigue, ambientata in un mondo post-apocalittico dettagliato e credibile come pochi. Giornali e riviste che fino ad allora non avevano mai scritto di videogiochi, dieci anni fa dedicarono a The Last of Us un enorme spazio, paragonandolo a film e libri come Apocalypse Now di Coppola e The Road di Cormac McCarthy. Una pioggia di lodi che rappresentò il definitivo visto d’ingresso dei videogiochi nel pantheon della cultura con la c maiuscola. Come se il fatto di “sembrare un film” o “ricordare un libro” fosse l’unica strada possibile per la riabilitazione artistica di un intero medium espressivo (cosa che i videogiochi a tutti gli effetti sono).
Giornali e riviste che fino ad allora non avevano mai scritto di videogiochi, dieci anni fa dedicarono a The Last of Us un enorme spazio, paragonandolo a film e libri come Apocalypse Now di Coppola e The Road di Cormac McCarthy.
Per paradosso l’enorme attenzione dedicata alla qualità della narrazione e delle tematiche finì per eclissare le qualità puramente ludiche di The Last of Us. Che non era solo una storia ben congegnata, e con cose interessanti da dire sulla moralità umana, ma anche un ottimo survival horror con un eccezionale lavoro di world building alle spalle: un gioco dotato di una grafica e di un livello di sviluppo tecnico d’eccellenza. The Last of Us era insomma un grande gioco in cui la cura della parte narrativa camminava di pari passo con quella di tutti gli altri elementi.
Sembrava oltretutto fornire una soluzione a uno dei problemi più discussi nella comunità videoludica di inizio anni Dieci: il dilemma della dissonanza ludo-narrativa. Un’espressione con cui il game designer Clint Hocking – primo a usarla in un post del 2007 – cercò di definire il “conflitto” tra aspetti narrativi e dinamiche ludiche che, a suo dire, emergeva con frequenza pari all’aumento di complessità e ambizione dei giochi contemporanei.
Per dirla in modo semplice: la dissonanza ludo-narrativa si verifica quando ciò che il gioco chiede di fare al giocatore non si armonizza in modo coerente con lo sviluppo della storia o i valori su cui essa poggia.
Uno dei casi più celebri e, a suo modo divertenti, di dissonanza ludo-narrativa è un videogioco di enorme successo prodotto dalla stessa Naughty Dog, Uncharted. Il suo protagonista – Nathan Drake – è un bonario archeologo e cacciatore di tesori, chiaramente ispirato a Indiana Jones fino ai limiti del plagio. Il problema è che le dinamiche ludiche di Uncharted, a metà tra action e sparatutto, richiedono al videogiocatore nei panni di Drake di falciare intere colonie di nemici (nell’ordine delle centinaia alla fine del gioco). Si ha così lo straniante paradosso per cui nelle cut-scene di dialogo (gli intermezzi “filmici” e non giocabili dei videogiochi), Drake si comporta come un simpatico guascone, salvo trasformarsi in un sanguinario sociopatico ogni volta che il giocatore ne assume il controllo.
Il problema di Uncharted, come di molti altri giochi, non è la violenza in sé (che nei videogiochi funziona per ragioni intrinsecamente cibernetiche ancor prima che antropologiche) ma il fatto che essa appare incongrua rispetto al personaggio che ci vuole “vendere” la storia. La dissonanza ludo-narrativa che sprigiona da Drake nasce dal fatto che Uncharted ce lo presenta come un character troppo positivo per le azioni che gli vediamo (anzi gli facciamo) compiere. Possiamo sospendere l’incredulità e il giudizio ma alla lunga diventa impossibile simpatizzare con un tipo che massacra dozzine di semplici sgherri senza ombra di rimorso. E che anzi sottolinea la mattanza con una infilata di battute più o meno brillanti.
La sigla HBO è quella che, più di ogni altra, ha sostanziato l’opinione, molto in voga nell’ultimo decennio, che le serie tv fossero la “nuova letteratura”.
The Last of Us risolveva questo problema in diversi modi; a cominciare dall’ambientazione post-apocalittica che ”giustificava” la morale crudele e violenta del mondo del gioco. Il fatto che la principale nemesi fossero degli zombie semplificava inoltre il dilemma morale di uccidere. Rendeva meno problematica la mancanza di empatia con le vittime che, per esempio, rendeva surreale un personaggio come Drake. Infine, e più importante, il protagonista di The Last of Us, era presentato da subito come un anti-eroe, un contrabbandiere disposto a tutto pur di tirare avanti in un mondo terribile.
Queste componenti, unite al fatto che in teoria si poteva ultimare il gioco senza sparare quasi mai, facevano sì che il livello di dissonanza ludo-narrativa di The Last of Us fosse minimo. E che anzi la carica suggestiva e morale della storia risultasse rafforzata dalle dinamiche di gioco e viceversa: un elemento particolarmente importante per una storia che presenta un finale (che non spoileriamo) da pugno nello stomaco. Il quale si regge in gran parte proprio sull’interazione tra lo sviluppo del racconto e l’imperativo ludico di compiere determinate azioni (si potrebbe scrivere un saggio solo su come, in un certo senso, l’ultimo “livello” di The Last of Us “giochi” consapevolmente sul crinale della dissonanza ludo-narrativa, ma l’embargo dello spoiler non lo consente).
Ma torniamo al tema della consacrazione di The Last of Us come “oggetto culturale” di notevole prestigio. La definitiva conferma in merito è arrivata tre anni fa, quando è stata annunciata in pompa magna la realizzazione di una serie tv tratta dal gioco. E non da parte di una casa di produzione qualsiasi ma nientemeno che di HBO, il broadcaster responsabile di Sopranos e The Wire, Watchmen e Leftovers. La sigla HBO è quella che, più di ogni altra, ha sostanziato l’opinione, molto in voga nell’ultimo decennio, che le serie tv fossero la “nuova letteratura”.
Altrettanto importante era il nome dello sceneggiatore coinvolto nel progetto insieme al game designer Neil Druckman (uno dei co-creatori del gioco), ovvero quel Craig Mazin che con Chernobyl ha realizzato, sempre per HBO, una delle serie drammatiche meglio scritte della storia. Simili premesse sembravano quantomeno garantire che la serie di The Last of Us non sarebbe stata l’ennesima mediocre trasposizione su pellicola di un videogioco (destino toccato allo stesso Uncharted) ma un prodotto che ambiva a raggiungere, se non a superare, i picchi narrativi toccati dal prodotto originale.
Ora che la prima stagione della serie si è conclusa possiamo finalmente domandarci: è andata davvero così? Secondo alcuni illustri recensori, la risposta è un sì convinto. Secondo altri, incluso il sottoscritto, è qualcosa di più simile a un ni. È innegabile che la serie di The Last of Us sia un ottimo prodotto, assolutamente degno della tradizione di HBO, ma sono abbastanza sicuro del fatto che non superi affatto il videogioco da cui è tratta, né come forma d’intrattenimento né, soprattutto, come prodotto culturale. Aldilà del secco giudizio, è interessante indagare la ragione per cui la serie non riesce a essere all’altezza del materiale a cui si ispira. E qui torniamo alla questione della dissonanza ludo-narrativa. La ragione per cui a molti reduci del gioco come il sottoscritto, la serie di The Last of Us è risultata meno convincente ed emozionante anche dal punto di vista narrativo (profilo in cui sarebbe dovuta eccellere) credo sia paradossalmente una conseguenza del fatto che… beh, non è un gioco.
È innegabile che la serie di The Last of Us sia un ottimo prodotto, assolutamente degno della tradizione di HBO, ma sono abbastanza sicuro del fatto che non superi affatto il videogioco da cui è tratta, né come forma d’intrattenimento né, soprattutto, come prodotto culturale.
Chi ha fatto l’esperienza di scoprire la storia di The Last of Us giocandoci, non ha potuto fare a meno di notare fino a che punto la narrazione della serie patisca l’assenza degli elementi ludici (che non sono mai solo ludici) e interattivi.
Come detto, The Last of Us è ambientato in un mondo post-apocalittico, dopo che un’epidemia di venti anni prima ha trasformato gran parte dell’umanità in zombie assetati di sangue. Zombie che sono quindi sia l’epicentro del lore del gioco che la sua principale componente ludica.
Il fatto è che, in tal modo, gli zombie svolgono anche una fondamentale funzione complementare allo sviluppo morale ed emotivo della vicenda. Ogni volta che ci “mette” in una stanza buia, circondati da zombie da eliminare o depistare, il gioco ci aiuta a immedesimarci sempre più nei panni di Joel. Alimenta il nostro istinto di protezione verso la giovane co-protagonista Ellie. E dato che la creazione di un legame padre-figlia tra i due personaggi è l’epicentro emotivo dell’intera narrazione è evidente come, in The Last of Us, la fase ludica risulti perfettamente funzionale, e appunto complementare, allo sviluppo emotivo dei protagonisti e del loro ruolo nella storia.
Per qualche ragione la serie decide invece di dare agli zombie un ruolo marginale. Di fatto sono una presenza ininfluente e su nove puntate compaiono in meno della metà. Se a prima vista può apparire strana, in realtà è una decisione che si può capire. Una volta che hai mostrato i personaggi alle prese con gli zombie, ogni successivo episodio risulta di fatto una sfiancante ripetizione della stessa dinamica narrativa. Un gioco si può permettere una simile ripetizione perché ogni volta propone al giocatore una sfida che lo diverte, una narrazione passiva non può fare altrettanto, pena la noia del suo pubblico.
E così laddove il gioco di The Last of Us creava, proprio attraverso l’esperienza ludica, un crescendo emotivo tale da rendere ancora più shockante il suo complesso e doloroso finale, la serie non riesce a fare lo stesso con altrettanta forza e convinzione.
Laddove il gioco di The Last of Us creava, proprio attraverso l’esperienza ludica, un crescendo emotivo tale da rendere ancora più shockante il suo complesso e doloroso finale, la serie non riesce a fare lo stesso con altrettanta forza e convinzione.
Lo stesso si può dire di altri momenti della serie che risultano meno “guadagnati” dal punto di vista narrativo, e toccanti da quello emotivo, del loro corrispettivo nel gioco. Non è di sicuro un caso se l’episodio più bilanciato ed appagante è anche l’unico a non essere un adattamento fedele degli eventi del gioco. Sto parlando del terzo episodio, “Long Long Time”, in cui la serie fa una deviazione dal canovaccio del gioco per approfondire il retroterra narrativo di un personaggio secondario. Una vicenda che nel gioco è appena abbozzata con una serie di riferimenti indiretti viene esplorata con più libertà creativa e narrativa da parte degli autori, risultando anche per questo il momento più convincente dell’intero prodotto. Possiamo quindi concludere che il principale problema della serie in fondo sia proprio quello di cercare di essere una riproduzione troppo fedele del gioco, senza poter però sfruttare quegli elementi ludici che ne garantivano l’unicità. Il che è interessante poiché ci conferma quanto stiano cambiando i rapporti di forza tra il mondo dei videogiochi e quelli della cultura, dell’arte e dei media. Se dieci anni fa The Last of Us veniva elevato a un rango tale da potere essere accostato a una serie tv, dieci anni dopo il mondo si è rovesciato e non risulta più blasfemo dire che il difetto principale di una serie tv sia, in fondo, quello di non poter essere un videogioco.